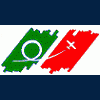-
Numero contenuti
574 -
Iscritto il
-
Ultima visita
-
Giorni Vinti
2
Tutti i contenuti di Dave97
-
Intercettazione notturna Il 2° Gruppo Caccia Terrestre con i suoi RE 2001 si rischierò sull'aeroporto di Treviso S. Angelo nel dicembre 1942 per essere addestrato all'intercettazione notturna. Dal Libretto Personale di Volo leggo: 19 lezioni di volo strumentale su SAIMAN 200 tenute dai Ten. Rissone, De Camillis e Valsechi, 1 volo radio guidato su S.79, 2 quote assistite in RF e 2 raids rispettivamente di 200 e 400 km su C.R. 42, infine 7 tiri di lancio sul poligono di Magnago. Il restante dell'addestramento furono voli acrobatici su C.R. 42 prima, RE 2001 dopo, con e senza la luna. Si aggiunga, alcuni voli su M.C.200, per chi come me ne aveva il passaggio, decollo e voli su RO 41, voli di collegamento con l'F.N. 305 e voli per gioco con il BUKER JUNGMEISTER. Quest'ultimo giunto dalla Jugoslavia, era troppo facile da pilotare per essere di qualche utilità al 1° Nucleo Addestramento Intercettori. Di notte, senza luna, con l'oscuramento in vigore, tranne poche e sparse luci in campagna, rimanevano ad aiutarci i soli cinesini allineati sul nostro campo erboso. L'acrobazia, eseguita necessariamente a quota più bassa, veniva molto facilitata dalla loro luce e tutte le manovre sfogavano nella dimensione di questo allineamento. Evoluzioni piuttosto inutili dato il nostro prossimo impiego, così pensavo allora, finché ebbi a ricredermi il 13 agosto 1943 quando ero già pronto al combattimento nella specialità Caccia Notturna. Al termine di un volo di addestramento non si aprì il carrello del mio RE-2001. Consumai il carburante e venni giù serenamente. Molto meno sereno lo sarei stato se avessi pensato che il velivolo era munito di ganci ventrali per l'attacco della bomba. I ganci agirono da vomere. Alcuni testimoni affermarono che mi ero fermato in 20 metri, altri in 10 o 15 al massimo. A me premeva solo accendere un cero allo speciale vincolo pilota "AEREA" che mi tirò all'istante giusto impedendomi di rompermi l'osso del collo per il contraccolpo e che il 2001 avesse subìto davvero, quanto appariva ad un primo esame, il solo danno di due pale dell'elica piegate. L'addestramento della mia Sguadriglia, la 358°, venne interrotto. Giunse l'ordine di partire subito per Venafiorita - Sardegna dopo essere passati per Ferrara a ritirare i primi RE 2001 con due cannoni da 20 in gondole subalari. Questi aerei non avevano il collimatore idoneo all'impiego notturno e perciò dal 3 maggio 1943 operammo soltanto di giorno partendo su allarme dagli aeroporti di Venafiorita, Decimomannu e San Vero Milis. Fummo quindi rischierati a Villanova d'Albenga dove ci vennero assegnati bellissimi DEWOlTINE 520 per missioni diurne assieme con i 2001 e tre C.R. 42 nella versione Caccia notturna con ricetrasmittente e tubi di scarico smorza fiamma. Sulla colorazione nera di questi aeroplani la fascia bianca e i fasci littorio non apparivano e solo un filo bianco disegnava la croce, sul timone di direzione. La fauna della Squadriglia si arricchì poco dopo di un CA. 164 e di un raro esemplare di neonato l' F.L. 3 Purtroppo con il Dewoitine 520 perse la vita il Maresciallo Ricci, nonostante il coraggioso intervento del capitano Piero Casana che lo tirò ancora vivo fuori dai rottami in fiamme Il Comando del 2° Gruppo con il suo Comandante, Maggiore Francesco Tessari, era a Genova alle dipendenze della Brigata "LEONE": la 152° Squadriglia a Sarzana e la 150° a Capua. Al nostro covo di Villanova d'Albenga, chiuso su tre lati da montagne con una collina a fine pista e la pista stessa pendente in direzione del mare, giunse notizia che all'aeroporto di Levaldigi era arrivato il mostro della Caccia notturna, il bimotore DORNIER 17 che si preparava a sortire con qualunque tempo munito di antenne specialissime e di equipaggio addestrato in Germania; inoltre, un sofisticato sentiero d'avvicinamento ne avrebbe facilitato il rientro alla base. Villanova d'Albenga 13 agosto 1943. Giocavamo a pinacolo: il Maresciallo Castelletti, i Serg. Magg. Capatti e Sgubbi ed io che quella notte ero di turno al posto del Capitano Angelo Merati che comandava la Squadriglia. Alle 23.45 decollai su allarme con il C.R. 42. Il tempo era incerto: due segnali di pericolo sui costoni prospicienti il campo erano stati accesi dagli avieri preposti. Poco dopo udii il “Buco”, cioè Sarzana che richiamava la propria "Barca". Anch'io ricevetti la comunicazione di cessato allarme e a mezzanotte e dieci ero a terra. Le luci sui costoni vennero spente. La pioggia batteva sui vetri della Saletta Operativa e la nostra partita a carte riprese. Alle 01.20 fu annunciato altro allarme. Toccava a me decidere se era il caso di fare partire un aereo e quale pilota scegliere: per non avere eventuali rimorsi, assegnai a me stesso questo tentativo d'intercettazione. Mi accompagnò al C.R. 42 la mascotte della Squadriglia, un fox-Terrier, che nel breve tratto dalla baracca all'aereo puzzava già di can-bagnato. Dense nuvole sfioravano le creste dei monti e quando fui in aria pensavo veramente che non mi sarebbe rimasta altra alternativa che quella di girare nella conca, più o meno come il motociclista del circo evoluisce nella botte: poi, uno squarcio ristretto fra le nubi mi invitò a passare e subito dopo si chiuse alle mie spalle. Al piano superiore, la luna non c'era a ricevermi. Più tardi, per lo sfilamento dell'impianto elettrico di illuminazione della bussola non potei effettuarne la lettura e rimasi con il solo aiuto del direzionale. A vista mi diressi là dove la contraerea illuminava un cielo fatto di cumuli e cumulacci, brutto skyline di nubi, ma mi resi presto conto che quella difesa era nella zona di Torino, un area che non doveva interessare noi del 2° Gruppo. Virai verso Sud, attento a cercare d'intravedere la costa; non vidi che buio, ma udii chiaramente l'ordine di portarmi a quota 5500 metri. Salii e appena livellato l'aeroplano un colpo di contraerea, molto vicino, mi sollevò di peso scaraventandomi sulla destra in posizione inusuale. Approfittando del bagliore tutto attorno mi augurai di vedere i bombardieri nemici, ma finii solo per stropicciarmi gli occhi e avere paura della reazione contraerea; allo stesso tempo fui contento di avere avuto un'indicazione di posizione, perche gli spari non potevano che provenire da Genova o Savona. Incrociai allargo sul mare, anche per evitare di confondere ancora l’artiglieria e seguii un circuito improvvisato allorché vedevo effettivamente fantasmi di aerei inglesi o americani che una volta avvicinati si rivelarono essere niente di più che stracci di nubi in volo su altre nuvole. Ricevetti l'ordine di rientrare e solo in quel momento guardai l'orologio. Era passata un'ora e mezza dal decollo. Dovevo affrettarmi, dovevo avvistare la costa, dovevo trovare Capo Mele e con l'aiuto dei segnali di pericolo sui costoni, infilarmi nella gola e atterrare. Iniziai la discesa, una discesa sempre più guardinga man mano che perdevo quota; a 400 metri ebbi ancora il dubbio che quanto intravidi fosse un ennesimo scherzo dei miei occhi, ma non fu cosi. La costa era sotto di me; il peggio era passato. Mi rimase solo la preoccupazione per l'autonomia restante. L'intercettazione avvenne all'improvviso: fra i corti montanti che formavano la gabana del C.R. 42 vidi grigio, non più nero. Per istinto tirai quanto potei la cloche e ebbi la sensazione di un atterraggio eseguito alla perfezione, un atterraggio dolce su terreno morbido. Mi voltai di scatto e vidi un pallone di sbarramento che danzava alle mie spalle. Qualcuno mi raccontò, giorni dopo, che giù al Comando di Gruppo chiusero gli occhi per riaprirli quando il rumore del mio aereo fu udito in allontanamento. Avevo cosi acquisito, sia pure a prezzo esoso, un'indicazione di posizione certa, senza ambiguità, perché in quei mesi lo sbarramento con palloni frenanti era stato realizzato solo a difesa della città di Genova. Mi rimasero pochi minuti per decidere come affrontare la prossima città: evitare la contraerea di Savona allontanandomi a bassa quota sul mare fra piovaschi e buio pesto, mi parve più imprudente che prendere Savona di petto sfiorandone i tetti. Savona accettò la mia carezza senza reagire. Cercai di comunicare con la Sala Operativa di Squadriglia per farmi vivo, ma sapevo che volando a quota più bassa delle montagne non avrebbero potuto ricevermi. Aguzzai gli occhi e trovai Capo Mele, virai verso le montagne e non vidi alcuna luce che ne indicasse il pericolo. Era successo che gli avieri di servizio ai costoni, ricevuta la telefonata di cessato allarme, spensero le luci dando per scontato che l'aeroplano da assistere fosse da un pezzo al sicuro con i tacchi alle ruote. Per non essere nuovamente colto di sorpresa guardando avanti attraverso la gabana e probabilmente questa volta non riuscire ad evitare l'ostacolo che non danza né perdona, mi inoltrai fra i monti spedalando. Dopo poco, invece di iniziare la planata con il muso alto, assetto che tanto piaceva al C.R. 42, discesi scivolando d'ala un po' a sinistra, un po' a destra spesso abbassandone il muso finché ad un tratto vidi un filo sottile verde brillante: era la catenaria, la soglia di casa. Una dozzina sola di lampadine colorate sarebbe stata più che sufficiente per farmi atterrare anche senza bisogno di disturbare i cinesini alle 3 .25 di notte come di fatto avvenne. Ancora un paio di scivolate d'ala per correggere la mia quota ed ebbe inizio la peggiore situazione in assoluto in cui venni a trovarmi durante questo volo che fu tutto pericoloso dall'inizio alla fine. Nella fase di avvicinamento, quando ormai ero in cortissimo finale, il fascio di luce di un riflettore da difesa contraerea, montato su un camion PIA T B.L. 18 della prima Grande Guerra, posteggiato nelle vicinanze della catenaria, mi investi in pieno. Per non rimanere accecato nascosi la testa nell'abitacolo; per non "scassare", detti tutto motore e virai stretto in forte assetto cabrato. Cominciò da questo momento la giostra con il rifletore che era deciso ad abbattermi. Quell'inseguimento insensato doveva cessare; dovevano cessare le mie manovre evasive, acrobazie eseguite in una conca chiusa da un coperchio di nubi e disturbate dai guizzi di luci nel loro impatto con le pareti. A questo fine il Serg. Magg. Capatti corse dalla Sala Operativa lungo tutto l'aeroporto fino a farsi scoppiaré il cuore. Meglio sarebbe stato se a Capatti fosse scoppiato il cuore durante quella generosa corsa verso il camion perché mesi dopo fu ucciso in combattimento aereo e, caso unico, inimmaginabile, l'aereo andò a schiantarsi proprio davanti la casa dei suoi genitori. Ormai esasperato, decisi di fare saltare gli uomini addetti al riflettore giù dal camion: mi portai in direzione opposta a quella di atterraggio e profittando di un loro momentaneo disorientamento mi avventai. Il fascio di luce rimase paralizzato nella posizione in cui non fu più manovrato. Per non allontanarmi nel buio che ormai mi intimidiva, richiamai l'aereo in verticale dopo la puntata;lo costrinsi poi a scivolare d'ala in virata stretta e ciò sia per non forare il coperchio di nubi e sia per potermi allineare con la direzione d'atterraggio. La manovra fu necessariamente violentissima: se ne lamentò con un sibilo il copertone della ruota sinistra nel toccare terra. Riuscii a mantenere diritta la corsa, poi diressi al parcheggio dove il C.R.42 non arrivò. La benzina era finita. L'elica era ferma. Il Serg. Magg. Sgubbi avvicinandosi all'aereo mi apostrofò: «Con lei Tenente non si sta mai tranquilli!». Quella notte stentai a prendere sonno. Ringraziai la Madonna di Loreto, ringraziai l'allenamento acrobatico notturno fatto a Treviso e da me cosi poco apprezzato, ringraziai il C.R. 42 che rimase a secco di carburante al momento giusto permettendomi e perdonandomi una scivolata d'ala irripetibile. Qualche ora dopo fui svegliato perché il Generale Attilio Biseo, Comandante la Brigata Leone, voleva vedermi. Ero stato alle sue dipendenze quando volavo con gli S. 79 del 33° Stormo B.T. in Libia nel 1940; lo avevo sempre ammirato questo trasvolatore "Atlantico", questo pilota e tecnico eccezionale. Mentre mi vestivo, lui era giunto alla soglia dell'alloggio, mise una mano sulla mia spalla e disse: Calendino, per tua consolazione, ti informo che di tutta l'alta Italia in allaeme, siete andati in volo solo Balli con il Dornier e tu col C.R. 42…. Ala Tricolore Maggio 1989
-
Kommodore ADOLF GALLAND - LUFTWAFFE - Il più famoso, e sotto molti punti di vista il più grande, dei cacciatori tedeschi della seconda guerra mondiale fu Adolf Galland, che abbatté centoquattro velivoli alleati sul fronte occidentale: ciò fa di lui uno dei maggiori vincitori nell’elenco dei piloti della caccia della Luftwaffe che combatterono contro gli inglesi e gli americani; da notare che egli raggiunse quella cifra nonostante che gli fosse stato proibito di combattere a cominciare dal dicembre del 1941 fino alla fine del 1944! Era un comandante per sua stessa natura e, a trent'anni, aveva già avuto il grado di generale dell'Arma della caccia risultando cosi il più giovane ufficiale delle forze armate tedesche che rivestisse quel grado. Combatté in Spagna, in Polonia, in Francia, in Italia, in Germania e si guadagnò le maggiori decorazioni della sua nazione: fu anzi il primo tedesco a ricevere la più alta di tutte. Era uno dei pochi che avesse la conoscenza della guerra aerea sia al livello della prima linea sia a quello di comando. Galland era nato nella città di Westerholt, in Westfalia, nel marzo del 1912; aveva tre fratelli dei quali altri due entrarono in aviazione e divennero ottimi piloti da caccia nella seconda guerra mondiale. Il loro padre era balivo del conte von Westerholt, un incarico tenuto dalla famiglia Galland per quasi centottant'anni. (I primi Galland erano ugonotti francesi che andarono in Westfalia per sfuggire alle persecuzioni religiose, stabilendosi in Germania intorno al 1742.) Adolf fece le scuole elementari a Westerholt, le medie a Buer e, affascinato dal volo a vela che allora era venuto di moda, decise di diventare un pilota delle linee civili; ottenuto il consenso del padre fece il suo primo volo quando aveva diciassette anni ma, sugli inizi, dovette faticare alquanto per imparare le tecniche del volo, come del resto era accaduto a parecchi dei più grandi piloti da caccia; superate queste difficoltà partecipò poco dopo a una gara di volo a vela, nella quale si comportò bene. Nel 1931, ormai diciannovenne, completò i corsi di addestramento a Wasser in Rhoen; nel frattempo aveva ottenuto diversi notevoli successi nelle gare alle quali continuava a partecipare, finché non fu poi nominato, a sua volta, istruttore di volo a vela. Ben presto divenne proprietario di un aliante e, dopo aver stabilito nella sua regione un primato di veleggiamento, sostenne l'esame per poter entrare nella scuola di volo delle linee civili della Lufthansa. Tra le migliaia di aspiranti che parteciparono al concorso soltanto una ventina vennero accettati e Galland fu uno di questi; nel 1932, dopo aver completato con successo i corsi di pilotaggio, fece domanda di essere arruolato nelle forze armate, dove venne accettato (la piccola aviazione militare tedesca era ancora sub rosa, in quell'epoca). Nel 1934 fu inviato in Italia per un corso segreto di addestramento, dopo il quale venne trasferito alla scuola di volo militare di Dresda, dove gli furono insegnate le acrobazie. Nel 1935 fu assegnato al 2° Stormo da caccia della Luftwaffe, alla quale il cancelliere Adolf Hitler stava facendo avere una rapida espansione. Poiché era ormai un pilota esperto cominciò a emergere nel suo ambiente e fu uno dei volontari che Hitler mandò in Spagna per aiutare la ribellione contro il governo repubblicano. Durante la guerra civile, nel 1937 e 1938, Galland non si fece una fama particolare, come cacciatore, il che accadde anche a un altro famoso pilota tedesco, Werner Moelders; portò tuttavia a termine trecento missioni volando sull’ He 51 con il quale si fece una grande esperienza nelle tattiche dell'appoggio diretto alle truppe e ricevette la Croce d'onore della campagna spagnola in oro e diamanti,che soltanto quattordici piloti si meritarono. Durante la campagna di Polonia del 1939 compì settanta voli di guerra in ventisette giorni e venne promosso capitano. Dislocato sul fronte occidentale quando, il 10 maggio 1940, Hitler lanciò le sue armate contro la Francia e i Paesi Bassi, conquistò la sua prima vittoria aerea in quelle zone il 12 maggio, abbattendo un Hurricane della RAF. Quello fu l'inizio di una carriera piena di successi contro le Aviazioni britannica e statunitense, durante la quale Galland fu abbattuto molte volte, obbligato a lanciarsi col paracadute dal velivolo in fiamme e ferito dal nemico in diverse occasioni. Per ordine personale di Hitler dovette restare a terra senza volare in operazioni e, quale riconoscimento delle sue novantasei vittorie, fu promosso, nel dicembre del 1941, generale comandante dell'Arma della caccia. Nel 1940, al termine della battaglia d'Inghilterra, avendo abbattuto cinquantasette nemici era il pilota da caccia che avesse riportato il maggior numero di successi. Nonostante che lo stesso Galland additi in Hans Joachim Marseille il più grande tra i cacciatori di guerra (ambedue dovevano divenire degli idoli per il popolo germanico), sono in molti quelli che pensano che invece non vi fosse nessuno che potesse stare a pari con lui. I suoi combattimenti ebbero termine, tranne che per qualche occasionale missione, nel dicembre del 1941; per questo il suo risultato finale di centoquattro abbattimenti è tanto più notevole di quanto non possa apparire considerando l'elenco dei migliori assi tedeschi. Non vi sono dubbi che fosse un pilota eccezionale, qualità che aveva già messo in evidenza all'epoca delle gare di volo a vela, oltre che un magnifico tiratore; per di più, non aveva chi lo superasse in decisione e aggressività. Quando fu messo a terra non si trovava mai a suo agio e rodeva il freno finché non riusciva a fare un volo; nell'ultimo periodo della guerra tornò in azione alla testa di un gruppo di aviogetti, con i quali si batté contro una schiacciante superiorità numerica. Nel 1941 Galland era Kommodore di uno dei due stormi da caccia lasciati in occidente per contrastare la RAF, dato che la maggior parte della Luftwaffe era stata trasferita sul fronte orientale per l'offensiva contro la Russia. Il suo stormo occupava, con i propri gruppi, diversi aeroporti nella zona del passo di Calais e il Kommodore, in quell'epoca, era spesso alla testa dei suoi piloti per guidarli contro la RAF; venne cosi a conoscere qualche nome dei più noti assi britannici, alcuni dei quali incontrò personalmente, quando, abbattuti sulla Francia, accettarono il suo invito a pranzo. Sfide nei cieli Il 21 giugno 1941 era un sabato; faceva caldo e il sole splendeva sullo stretto davanti a Dover. Nei pressi delle coste del Kent e sulle coste francesi della zona del passo di Calais, tra Calais e Boulogne, erano dislocati, strategicamente, gli aeroporti avanzati della caccia, rispettivamente della RAF e della Luftwaffe. La RAF aveva dato inizio all'offensiva con l'intenzione di dare un certo sollievo alle armate russe sul fronte orientale; perciò i suoi velivoli attaccavano in continuazione, di giorno, gli obiettivi situati in Francia. Poiché la caccia di scorta (Spitfire e Hurricane) non aveva un notevole raggio d'azione, i colpi venivano di solito portati contro bersagli situati nei pressi delle coste e i caccia della Luftwaffe, stavano adesso esperimentando il ruolo opposto, attaccando gli incursori della RAF sulla Francia. All'inizio dell'estate del 1941 soltanto due stormi della Luftwaffe, il 2° e il 26°, difendevano la Francia e l'Europa occupata contro gli attacchi della RAF che, nella stampa alleata, venivano chiamati «l'offensiva senza soste». Kommodore (comandante) del 26° Stormo era il tenente colonnello Adolf Galland, che aveva il suo comando in una fattoria nei pressi di Audemberf. La mattina del 21 ebbe inizio senza prodromi di azioni e non veniva rilevata alcuna indicazione di attività nemica. Man mano che la mattina avanzava, la brezza aveva preso a soffiare sempre più forte dallo stretto mentre il sole scaldava le verdi, ondeggianti colline di Calais. Galland era nervoso: il tempo era troppo buono. Il suo stormo era composto di tre gruppi, ciascuno dei quali comprendeva tre squadriglie; la forza normale di volo di una squadriglia era da otto a dodici aerei perciò, impiegando tutte e nove le squadriglie, Galland poteva mandare in volo più di un centinaio di aeroplani. Disponeva inoltre di una Stabschwarm (pattuglia del comando) di quattro caccia della quale egli era, normalmente, il comandante. (In generale, la forza complessiva di uno stormo poteva essere calcolata, in quell'epoca, di centoventi velivoli.) Una squadriglia era basata a Audembert, con Galland, mentre le altre otto erano dislocate su altri tre aeroporti nei dintorni; il Kommodore faceva ruotare, ogni due settimane, le squadriglie sui vari campi in modo da poter fare una diretta, personale conoscenza di quanti più piloti gli fosse possibile. Nel 1940 tutte le squadriglie del 26° Stormo erano montate sul Me 109, ma nel 1941 tre di esse, un gruppo , lo avevano sostituito col FW 190. I Me 109 E stavano al riparo entro baracche di legno mimetizzate nella zona meridionale dell'aeroporto di Audembert, con il ventre pitturato di grigio o di un leggero color celeste che, visti dal basso, si confondeva con lo sfondo del cielo. Montavano un motore a cilindri in linea, invertiti, il Daimler-Benz da 1150 Hp (DB 605) che trasmetteva la potenza a un'elica tripala la quale a una quota di tremilaseicento metri, dava al velivolo la velocità di più di trecentocinquanta miglia orarie. I piloti della Luftwaffe ritenevano che i loro Me 109, più piccoli degli Hurricane e degli Spitfire, fossero più veloci del più veloce tra i due. (il Mark I Spit era dato per trecentocinquantacinque miglia orarie, ma a quattromilaottocento metri; in quell'epoca la RAF stava equipaggiando i suoi gruppi con il Mark II Spit, che poteva arrivare a trecentosettanta, mentre la Luftwaffe stava introducendo il Me 109 F che aveva una velocità di una ventina di miglia superiore a quella del precedente tipo E.) La doppia massa di tettoie che nascondeva i 109 a Audembert era stata mascherata molto bene, al punto da confondersi tra le leggere gibbosità del terreno circostante; sui fianchi erano stati dipinti degli alberi e veniva fatto un largo uso di reti mimetiche tanto che solamente da bassa quota era possibile discernere quelle installazioni. Galland, venne svegliato alle 7.30 di quella mattina. Il primo ufficiale che gli si presentò fu il capo meteorologo, che gli dette la conferma di quel che aveva già constatato di persona e cioè che le condizioni di volo erano eccellenti, fornendogli anche le ultime notizie spigolate dalle intercettazioni del traffico radio e dagli interrogatori dei prigionieri di guerra. (Il Corpo tedesco delle telecomunicazioni forniva informazioni molto utili sulle attività della RAF, scendendo anche fino a particolari minuti quali il nome del comandante di gruppo che era stato inviato in licenza.) Nonostante il suo nervosismo, pareva che sull'altra sponda dello stretto non vi fosse in vista alcuna novità. Si rassegnò quindi a occuparsi delle scartoffie, un lavoro che si riferiva all'attività del venerdì, tanto per far passare il tempo: le dieci, le undici, mentre all'esterno la temperatura saliva. A parte la momentanea messa in moto di un motore per qualche piccolo controllo, gli unici rumori che gli giungevano dalla finestra aperta della casetta erano quelli del vento, il ronzare degli insetti o il canto degli uccelli. Però, nonostante questa tranquillità, Galland non riusciva a rilassarsi. Ormai erano le undici e un quarto. Il telefono prese a squillare: era un ufficiale della sala di sorveglianza, una baracca di legno costruita a un paio di centinaia di metri dalla porta d'ingresso, sulla sinistra. Una voce disse: «In volo, verso Kent», e Galland rispose: «Vengo subito ». In meno di un minuto stava già infilando la porta della sala operativa addetta alla sorveglianza del cielo nemico, che aveva le dimensioni di circa trenta metri per .trenta; sotto il soffitto a volta, ricoperto all'esterno dalle reti mimetiche che si allargavano da ogni parte, si trovava un gran numero di tavolini coperti di carte sulle quali venivano riportate le indicazioni fornite da una stazione di radar Freya dislocata sulla costa. Galland passò dall'una all'altra carta e studiò poi la situazione finale, offerta dalla mappa generale sulla quale venivano combinati tutti i dati; il quadro complessivo era abbastanza chiaro. Dopo aver ordinato l'allarme e disposto un'adunata dei piloti per le istruzioni del caso, se ne andò di furia avvertendo che voleva essere tenuto al corrente di qualunque cambiamento che si fosse verificato nella situazione. C'era poco tempo disponibile perché la distanza era breve; gli specialisti stavano già controllando che i 109 avessero i motori caldi e fossero pronti alla partenza; il rombare distante cominciava a farsi sentire nella campagna e l'improvviso cambiamento nello stato di pace degli aeroporti della caccia fu tradito dalla frenetica attività che vi si rivelava: la tensione dell'azione imminente aveva cominciato a far sentire le sue unghie sulla piana tranquilla. Nel frattempo Galland stava spiegando la situazione ai piloti radunati in tutta fretta nella fattoria: «Sono state avvistate tre formazioni di bombardieri, probabilmente sotto la protezione della caccia, a tremila metri di quota. Si ritiene che entreranno su terra a poche miglia a occidente di Dunkerque ». Presa una carta continuò: «Probabilmente li potremo intercettare tra questi due punti» (indicò una zona verso oriente, alquanto sotto la costa). «Tutte le squadriglie si stanno radunando. Se avremo tempo ne prenderò il comando in modo da avere una formazione concentrata, altrimenti attaccheremo in gruppi separati». Vi furono alcune domande, ma il tempo era poco. Galland, avvolgendosi una sciarpa gialla attorno al collo, corse verso i velivoli, circondato da una quindicina di piloti: sarebbe stato alla testa della sua Schwarm di quattro, in aggiunta alla squadriglia di dodici. Lo stato di allarme, Gefechtsalarm, era già stato diramato e quindi tutto il personale era già al proprio posto, accanto ai 109; Galland salutò il suo capospecialista, sergente maggiore Mayer, saltò nell'abitacolo del suo 109 F 2 già pronto e, dopo essersi legato le cinghie, mise in moto il motore premendo il bottone dell'avviamento. Dopo un veloce controllo degli strumenti e dei volantini di comando dei compensatori e dei flap fece segno di esser pronto: uno specialista che si teneva vicino al velivolo alzò una pistola e sparò un razzo in aria; una piccola palla di fuoco verde si sollevò di una trentina di metri. Galland chiuse il tettuccio, mollò i freni e spinse con la mano la manetta gialla che si trovava sulla sinistra; subito il motore prese a rombare e l'elica trascinò avanti il caccia mentre altri aeroplani si mettevano a seguirlo tenendosi a breve distanza. Galland si spostò sull'orlo meridionale del campo, poi piegò a destra fermandosi sul limite orientale dell'aeroporto; gli altri tre velivoli che, col suo, costituivano la Schwarm erano accanto a lui e dietro di loro stava rullando rapidamente tutta la squadriglia, a coppie o in quattro, per prender posizione. Erano le 12.24: Galland spinse a fondo la manetta e il 109 prese a saltellare sull'erba prendendo sempre più velocità man mano che la potenza del suo grosso motore trascinava il caccia leggero (due tonnellate e mezzo) fino a sollevarlo dal prato portandolo nel blu del cielo occidentale. Dietro al Kommodore stavano decollando gli altri velivoli, agili e dal muso a punta, mimetizzati in grigio-verdastro e con le croci nere delle dimensioni di quasi un metro dipinte su ambo i lati delle fusoliere. Galland spinge un bottone situato di fianco, sul cruscotto, e il carrello del suo aeroplano cominciò a rientrare; riduce il motore iniziando una lenta virata e, sempre facendo quota, chiama l'ufficio operazioni che risponde: «Die dicken Hunde» (i cani grassi) mentre lui continua la sua rotta. (I controllori tedeschi addetti alle sale radar indicavano le formazioni di bombardieri, o di bombardieri e caccia, con i nomignoli di « cani grassi» mentre quelle soltanto di cacciatori erano chiamate «indiani ».) Galland chiude la presa d'aria dell'abitacolo, aggiusta il volantino che ha sulla sinistra per regolare il compensatore del piano di coda in assetto di salita e si mette in rotta per centodieci gradi; il suo 109, un Mickey Mouse come distintivo personale su un fianco, sale nel primo tratto a mille metri al minuto poi, man mano che l'aria si farà più rarefatta, rallenterà questa salita. Galland calcola che gli occorreranno più di cinque minuti per raggiungere la quota che vuole avere per trovarsi al di sopra degli incursori in arrivo e cioè da quattromila a quattromila trecento metri. L'indicatore di velocità, posizionato sul cruscotto davanti a lui, indica quasi quattrocento chilometri l'ora (la massima è di settecentocinquanta); Galland controlla che la temperatura del motore e dell'olio sia nei giusti limiti: il sistema tedesco è semplice perché le tubazioni e gli strumenti dell'acqua sono dipinti di verde, quelli dell'olio di marrone, quelli dell'aria di blu e quelli per la benzina di giallo; l'estintore d'incendio è invece pitturato di rosso. Alza il coperchietto dei grilletti delle armi, per averle pronte, e accende la lampadina del collimatore: esattamente davanti al suo viso, sul rettangolo di vetro che misura dieci centimetri di altezza per cinque di larghezza, compare un cerchietto giallo-biancastro che gli dà la misura esatta dell'apertura alare di uno Spitfire (quasi undici metri) vista da cento metri di distanza. Galland può sparare il suo cannoncino da venti millimetri, premendo col pollice un bottone nichelato proprio sulla punta della leva, e le due mitragliatrici da sette e otto tirando con l’indice il grilletto in alto, sul davanti della leva stessa, il cui manico, dall'impugnatura anatomica, è di color nero. Adesso è pronto per l'azione; i 109 della Schwarm, con l'ogiva dipinta di giallo, si spingono sempre più in alto nel cielo, verso oriente; la squadriglia è in posizione dietro i suoi quattro caccia 2000 metri, 2200, 2400. I bombardieri inglesi, dei Blenheim bimotori, stanno preparandosi per l'attacco a un aeroporto e sono già in rotta di puntamento; si tratta di Arques, presso St.Omer. I Blenheim, viene informato Galland per radio, sono già a est, davanti ai caccia dall' ogiva gialla che stanno ancora facendo quota e così non vi sarà tempo per radunare l'intero stormo. Il controllore di Wissant riferisce anche dell'avvistamento di grandi formazioni di scorta della RAF, che si trovano più alte dei bombardieri. Galland accusa ricevuta e continua nella salita; la quota sale... 2700, 3000, 3400 e la rotta seguita è quella suggerita dai segnalatori a terra, che li fanno dirigere un poco più a sud. Adesso la formazione nemica dovrebbe essere in vista e tutti scrutano continuamente il cielo davanti a loro; Galland si guarda alle spalle e continua diritto. In prua può già scorgere St.Omer e, poco più in là, lungo una strada che piega a sud-est, c'è l'aeroporto: e le esplosioni delle bombe. La base è sotto attacco; i bombardieri della RAF, che comincia adesso a vedere, sono su Arques a tremila trecento metri e, al di sopra di loro, vi sono delle formazioni di Hurricane e di Spitfire. Galland e i piloti tedeschi, nel vedere il nemico, avvertono la tensione della battaglia imminente; danno motore in pieno per aumentare la salita e passare sopra i caccia britannici e mettersi in condizioni di poter effettuare un attacco in picchiata. I 109 rombano portandosi sempre più alti rispetto ai bombardieri, che adesso iniziano una virata a destra: anche Galland comincia a virare a destra, sempre tenendo il velivolo cabrato, superando la quota dei caccia di scorta e, maggiormente, quella dei bombardieri che sono sotto di lui, sulla destra; sembra che questi abbiano finito la loro azione e che stiano mettendosi in rotta di rientro. La Staffel è in posizione, ma i caccia britannici si trovano tra i 109 e i Blenheim: ce la farà a passare in mezzo alla scorta per buttarsi sui bombardieri? Fino a quel momento nessun altro caccia tedesco sta ancora attaccando: bisogna passarvi dentro; preme il bottone della radio e comanda: «Attacco!» Si butta in picchiata sulla destra; le ali, nella virata iniziale, mettono chiaramente in mostra le croci nere e bianche e i 109 acquistano velocità sempre più decisamente, sotto la guida di Galland. Scendono e, mentre picchiano rapidamente col muso tenuto fortemente in basso, i piloti hanno lo sguardo fisso in avanti attraverso il vetro del collimatore: Spit e Hurricane, alti sopra i Blenheim, sembrano volersi lanciare al loro incontro con una virata fatta proprio sulla testa dei bombardieri, ma Galland non li degna della sua attenzione e passa come un bolide attraverso la formazione nemica a 650 km/h. Presi di sorpresa, i cacciatori della RAF virano strettamente per agganciare i 109; ma questi sono cosi veloci che sono già in basso, lontani da loro e in rapido avvicinamento ai «cani grassi ». Galland tira leggermente la leva, avverte il defluire del sangue dalla testa, ma tiene gli occhi fissi sulla formazione nemica; uno dei bombardieri bimotori è un po' lontano dagli altri, sulla destra e si trascina un po' dietro i compagni: manovrando con i comandi mette il suo 109 in volo orizzontale e, sempre lanciato a tutta velocità, gli corre addosso sulla coda. La distanza diminuisce rapidamente durante l'attacco deciso; il mitragliere della torretta superiore sembra che non si sia accorto di lui e Galland tiene gli occhi puntati attraverso il cerchietto luminoso, con le dita pronte a premere i grilletti... più vicino... più vicino. L'ala del Blenheim diviene sempre più grande, ha adesso le dimensioni del diametro dell'indicatore luminoso; gli è addosso: pollice e indice premono ! Il cannoncino e le mitragliatrici rombano e vibrano e la mira è di quelle mortali: i colpi raggiungono in pieno il bombardiere che barcolla sotto la raffica mentre pezzi di lamiera ne saltano via: poi c'è una fiammata: benzina! Galland è arrivato così vicino che deve virare di colpo per evitarsi una morte per collisione: piega sulla sinistra mentre le ali del Blenheim s'impennano e poi precipitano... Il fumo lo segue, emergendo da grosse lingue di fiamma. Un paracadute si apre, poi un altro: due, dei tre uomini di equipaggio, si sono lanciati e non vi è stata nessuna raffica in risposta da parte della sessantottesima vittima di Galland. Durante l'attacco ha perso di vista i compagni che si sono, ciascuno, scelti un bersaglio per proprio conto; la maggior parte della Staffel è impegnata con i caccia nemici, ma Galland è solo e, dopo aver scrutato il cielo, sale a tutto motore per portarsi ancora dietro ai bombardieri, più in alto. Farà un'altra puntata se .i difensori nemici non intervengono; a poco a poco il velivolo solitario fa quota mettendosi al di sopra delle pattuglie dei Blenheim e della mischia dei caccia, che si combattono intorno a loro. Galland riesce a tenersi fuori degli scontri e, raggiunti di nuovo i 3600 metri, è pronto a fare un'altra puntata; un'occhiata alle spalle... nessuno in vista. Un po' più di quota ancora, supera i caccia nemici e di nuovo si lancia in picchiata; la velocità aumenta e lui passa, come un bolide, in mezzo alla mischia: questa volta, però, uno dei piloti della RAF ha avvistata il Messerschmitt in candela e piazza in virata il suo Spitfire dando tutto motore e mettendosi al suo inseguimento. Galland sta picchiando veloce e riesce a staccarlo, sempre tenendo d'occhio i bombardieri nemici attraverso il vetro del collimatore; si avvicina rapidamente mentre livella il velivolo a tutta velocità e decide di buttarsi sul comandante della formazione, passando così in mezzo ai Blenheim e prendendo di mira il velivolo di testa della massa di attacco. Ha la velocità che gli occorre e manovra i comandi in modo da portare il 109 proprio in coda al comandante nemico, il cui velivolo s'ingrandisce nel collimatore mentre gli si avvicina tanto rapidamente che il mitragliere della torretta non ha nemmeno il tempo di prenderlo sotto tiro. L'ala riempie il cerchietto luminoso, Galland preme i grilletti e, ancora una volta, i colpi del cannoncino e delle mitragliatrici penetrano nella vittima: è cosi vicino che gli sarebbe impossibile mancarla. Concentra la raffica nell'ala destra e il fumo comincia a sfuggirne. Galland perde un secondo a guardare il bombardiere mentre vira di fianco: il Blenheim comincia a barcollare... e cade fuori della formazione, sulla destra, lasciando dietro di sé una scia di fumo nero. Ancora una volta l'equipaggio, o qualcuno di essa, si lancia col paracadute e Galland vede un ambrellone bianco, poi un secondo: è la vittima numero due, la sessantanovesima vittaria di guerra. Zeng! Zeng! I traccianti gli arrivano dal di sopra, di fianco. Un secondo per rendersi conto di questa nuova situaziane. Fumo! È stato colpito. Ha un caccia dietro di sé! Di colpo dà una pedata sulla pedaliera e sbatte la leva in avanti buttandosi in picchiata e virando, per sottrarsi all'attacco. Il sistema d'iniezione di benzina del motore Daimler-Benz dimostra ancora una volta il suo valore mentre egli s'infila in un cumulo di foschia che, insieme con la sua manovra decisa, gli salverà la vita. (I Messerschmitt 109 usufruivano di questo vantaggio tattico sugli Spitfire e gli Hurricane perché, nell'improvvisa affondata, la forza centrifuga interrompeva momentaneamente l'afflusso di benzina ai motori di questi ultimi; ma il Daimler-Benz aveva l’iniettore di carburante e, anche in quelle manavre, continuava a funzionare normalmente. Quel breve momento e la distanza che ha preso, consentono a Galland di cavarsi d'impaccio: i piloti britannici tentavano spesso di annullare quel vantaggio, dei tedeschi facendo, un tonneau, a un rovesciamento mentre picchiavano nell'inseguimento. Galland si dà un' occhiata alle spalle: è sfuggito allo Spit, ma ha perso molta quota e intanto, il vapore che fuoriesce ha lasciato una lunga scia bianca, una fumata quasi grigiastra che sembra quella emessa da un camino, dietro al suo F 2. Si rende conta che è stato colpito nel radiatare destro e che il liquida di raffreddamento, ne sta uscendo, nel frattempo il motore comincia a surriscaldarsi. Riduce la picchiata e, sempre guardandosi alle spalle, comincia a cercare un posta dove atterrare; il motore dà qualche accenno di noie e la sua temperatura sta salendo, rapidamente: deve aver perduto il liquido e, in tal caso, non può più farvi su alcun assegnamento. Proprio davanti a sé vede uno spiazzo aperto in mezzo alla campagna, a un paio di miglia a est di Calais; lo scruta attentamente; è un aeroporto proprio quello di Calais-Mark. Era talmente impegnato nel combattimento, che non ha potuto rendersi conto della sua posizione; il motore adesso zoppica disperatamente, rumoreggiando sempre più forte. Galland riduce al minimo la manetta ma, proprio in quel momento, il Daimler-Benz si ferma del tutto: l'elica gira sempre più piano e poi si arresta. Non ha più potenza ! Fortunatamente, l'aeroporto è esattamente davanti; si guarda alle spalle e visto che, grazie a Dio, nessun caccia nemico si è reso conto della brutta situazione nella quale è venuto a trovarsi il suo 109 cosi malridotto, Galland gira sull'aeroporto per potervi atterrare; continua a circuitarvi finché non sarà sufficientemente basso da potervi entrare, quando avrà ormai un centinaio di metri di quota. Il Messerschmitt plana silenziosamente e Galland fa appello alla sua vecchia esperienza di pilota di aliante mentre la discesa viene segnata da una scia di vapori biancastri; non fa uscire il carrello, atterrerà sul ventre col tettuccio aperto, e intanto si prepara a lanciarsi qualora l'aeroplano dovesse stallare. Planando veloce si tiene sulla periferia dell'aeroporto, poi fa la virata finale, si rimette in volo livellato e picchia, puntando col muso del velivolo il prato erboso. Tira lentamente ,la leva, la velocità diminuisce sempre più e la quota anche, trenta metri, quindici, sei o sette... poi il contatto, la strisciata, uno scricchiolio. Il 109 scivola sul terreno, sempre diritto,poi rallenta la corsa e finalmente si ferma. Appena il caccia si arresta, Galland si alza in piedi nell'abitacolo e ne salta fuori velocemente, mentre il personale accorre da tutte le direzioni; lui è tranquillo perché sa di aver atterrato in mezzo ai tedeschi. La sua prima richiesta alla folla che gli si stringe attorno è che venga subito avvertito, per radio, Audembert perché un velivolo da collegamento venga a prenderlo, il che viene fatto immediatamente. (Audembert è a dieci miglia soltanto lungo la costa, verso sud-ovest.) Fa un giro intorno al suo 109: l'elica è contorta, la pancia dell'aeroplano è tutta scorticata e il radiatore destro, a meno di mezzo metro dall'elica che si è ripiegata sotto il ventre, è malamente squarciato. Lo Spit deve essergli arrivato addosso dalla coda e dal basso ! Galland risponde alle domande circa l’azione e racconta dei suoi due abbattimenti; il personale della base si prepara a spostare il 109 danneggiato fuori della zona di attività e intanto un Me 108 compare nel cielo, verso occidente: viene da Audembert e Galland ben presto è in volo per tornarsene alla sua base, sempre in tempo per far colazione, anche se un po' in ritardo. Giunto al suo comando viene a sapere che pure il suo gregario, Hegenauer, è stato abbattuto; è stata una giornata piuttosto dura... due vittorie in pochi minuti, ma ambedue, lui e il suo compagno, sono stati abbattuti. Il combattimento viene discusso con molta accuratezza dai piloti tedeschi, molto eccitati. Dopo colazione Galland, del tutto illeso, se ne torna al tavolo di lavoro, alle sue scartoffie, ai suoi documenti segreti: il tempo si mantiene magnifico... ma certamente la RAF ne ha avuto abbastanza, per quel giorno. Lavora fino alle tre, alle tre e mezzo, alle quattro: e poi... Il telefono squilla: è L'ufficiale della sorveglianza radar. Una grossa formazione sista nuovamente preparando sul passo di Calais; Galland corre in sala operativa e dà un'occhiata ai tavoli del radar... vi sono in vista alcune formazioni che stanno già dirigendosi sulla Francia; dai dati rilevati sembra che entreranno su terra a una quindicina di miglia verso sud. Per la seconda volta nello stesso giorno Galland fa suonare il Gefechtsalarm e i piloti si precipitano per andare in volo; ma lui chi avrà per compagno? Il suo gregario non è ancora tornato e non c'è tempo per stare a definire la questione: per una delle poche volte nella sua carriera di pilota decide di andare in volo da solo; questo è contrario alle regole tattiche della caccia, ma forse potrà riuscire a riunirsi al suo gruppo, quando questo sarà in quota. Così, senza stare ad aspettare un gregario, Galland corre al suo Me 109 che nel frattempo gli è stato preparato (ne ha sempre due a sua disposizione) e ben presto solleva un nuvolone di polvere mentre rulla per decollare. Quasi subito il solitario 109 si stacca dalla striscia erbosa e si slancia nel cielo occidentale, ancora azzurro. Le quattro del pomeriggio sono passate da pochi minuti quando Galland vira verso sud, verso la zona sulla quale il nemico dovrà passare per penetrare in territorio francese; mentre il carrello sta rientrando fa un rapido controllo degli strumenti del cruscotto, prepara le armi, accende il collimatore: tutto è in ordine e allora continua la sua solitaria salita, sulla rotta che ha già preso. Ben presto è a 3000 metri, 3500, 3600; chiama l'ufficio operazioni... la formazione nemica dovrebbe essergli dinanzi, a poche miglia, alquanto più alta: sembra che siano dei caccia. Non riesce ancora a vederli, ma davanti a lui, in basso, compare Boulogne; il motore, spinto al massimo, continua a portare il 109 sempre più in quota, verso sud: eccolo a 4500,4700,5100, sempre in rotta in modo da avere Boulogne sulla destro mentre continua la salita. Scruta il cielo davanti... vorrebbe incontrare velivoli amici, prima dei nemici; a sud-est di Boulogne... dei puntini... sono degli aeroplani: li scruta con gli occhi magnetizzati da quelle macchioline che si stanno avvicinando... sono dei caccia; poi riesce a distinguere le sagome... sono dei Me 109! È il primo gruppo del suo stormo! Andrà a riunirsi a loro. Ormai ha più di 6000 metri di quota, si mette in volo livellato e dirige il musetto giallo del suo aeroplano verso i compagni; ma sulla loro destra compare un'altra formazione. Spitfire! Ne vede soltanto sei e sono più bassi; ha il vantaggio della quota e,cambiando di colpo il piano che già si era tracciato in mente, vira leggermente a sinistra per andare a mettersi sopra di loro. Forse potrebbe picchiarvi addosso a tutta velocità sfruttando l'elemento della sorpresa e, abbattendo l'ultimo della formazione, cavarsela prima ancora che gli altri possano rivoltarglisi contro. Gli Spit sono adesso davanti a lui, più in basso e Galland si butta in una picchiata che dovrebbe portarlo in posizione proprio in coda al sesto caccia nemico: ma dovrà fare alla svelta. La velocità aumenta e, mentre continua a perder quota, segue la situazione mirando da dietro il vetro del collimatore: l'ultimo Spit è in vista... ancora piccolo dentro il cerchietto giallo luminoso; tira leggermente la leva avvicinandosi a quasi settecento chilometri l'ora, poi si mette in volo orizzontale e piomba alle spalle del nemico. il sangue defluisce dalla testa e, mentre esce dalla picchiata si sente premuto fortemente sul seggiolino; ma si sta avvicinando alla coda dello Spit che sta adesso divenendo sempre più grande nel cerchietto di mira. I caccia della RAF si mantengono sempre alla stessa quota, dandogli tempo a sufficienza; gli undici metri di apertura alare coprono già il diametro del cerchiolino: cento metri. Galland preme i grilletti, il cannoncino e le mitragliatrici fanno il loro lavoro nel caccia nemico; alcuni pezzetti si staccano e si perdono nella scia; capisce quasi subito che il velivolo è perduto perché il fumo comincia a uscire dal motore: probabilmente il pilota non è nemmeno riuscito a capire che cosa gli sta accadendo. Le ali dello Spitfìre si rovesciano e la terza vittima della giornata di Galland precipita verso terra: è la sua settantesima vittoria. Subito riprende la picchiata per evitare di essere attaccato dagli altri. Si guarda alle spalle, non vede nulla di allarmante e rimane a guardare ,lo Spitfire che precipita al suolo a poche miglia a sud-est di Bouiogne. Contrariamente al suo solito 109, sui quale volava nella mattina, questo è sprovvisto di macchina da ripresa e lui vuol vedere dove lo Spitfire va a cadere. Ma, così facendo, deve pagare il prezzo di quel suo attacco solitario. Per la seconda volta nella giornata un rombare di sinistro auspicio lo prende di sorpresa: zeng! zeng! zeng! Sente benissimo e avverte che il 109 sta incassando dei colpi... molti colpi. Un dolore improvviso nella testa, nel braccio destro. Disperato, preso in trappola, Galland butta la leva in avanti e picchia in candela... via, poi la tira al ventre, virando. Riesce a togliersi dalla linea di tiro, ma è troppo tardi; il 109 è stato gravemente danneggiato e Galland sanguina abbondantemente. La manovra frenetica lo ha distaccato dai caccia che lo inseguivano, ma il motore sta vibrando e sbraitando rumorosamente: tra breve sarà andato del tutto. Toglie i contatti per ridurre il pericolo dell'incendio che tutti temono: Specialmente i piloti del 109 che stanno seduti proprio davanti al serbatoio della benzina; l'aeroplano comincia a planare verso il suolo, silenziosamente, proprio come, nella stessa mattina, aveva già fatto un altro suo simile. Sul lato destro dell'abitacolo e della fusoliera c'è un grosso squarcio attraverso il quale penetra l'aria; anche nelle alii vi sono dei buchi: la mira del caccia nemico è stata davvero mortalmente precisa. Ma il 109 risponde bene ai comandi e Galland ritiene di poter fare un altro atterraggio sul ventre; è ancora molto alto, sopra i 5000 metri di quota e sta picchiando verso nord. A un tratto, un segnale di pericolo: benzina e liquidi di raffreddamento filtrano sulla piantana; lui, con la testa e il braccio sanguinanti, se ne rende conto e capisce il pericolo. Poi, bang! Ancora il nemico ? Dà un'occhiata alle spalle, le fiamme si sono sviluppate di colpo avvolgendo la fusoliera. Rimane quasi senza respiro mentre qualche lingua di fuoco gli si accende tra le gambe, da sotto e da dietro il seggiolino. Deve lanciarsi ! Galland si slaccia le cinghie, alza la sinistra per sganciare la chiusura del tettuccio, ma la Kabinennotabwurf non funziona! Il tettuccio non salterà via, qualcosa si è inceppato! Spinge con tutte le sue forze, con ambedue le mani, ma il meccanismo non si muove e, intanto, il calore nell'abitacolo si fa sempre più forte. Deve riuscire a lanciarsi o dovrà morirvi bruciato: spinge con tutta la violenza di cui è capace verso l'alto, mentre le fiamme cominciano a svilupparsi fin da dietro il cruscotto; non gli rimangono che brevi secondi, ma non riesce ancora ad aprire il tettuccio. Con uno sforzo disperato si butta con tutto il suo corpo contro la chiusura dell'abitacolo e la porta anteriore finalmente si apre un poco; poi il vento la solleva, la ripiega all'indietro e la fa saltar via, nella scia dell'aeroplano. Contemporaneamente Galland dà un colpo alla leva, si mette in piedi sul seggiolino e cerca di buttarsi fuori mentre il 109 si è messo in verticale, col muso puntato verso il cielo. Riesce a uscirne in parte, ma il paracadute, sul quale stava seduto, rimane agganciato con una cinghia a un pezzo del tettuccio che non si è sganciato e che è rimasto bloccato nella sua sede. Mentre sta ancora lottando, mezzo dentro e mezzo fuori, ostacolato dal vento che lo trascina, il 109 stalla, si piega su un' ala e poi cade in vite. Galland ,ancora prigioniero, precipita con il velivolo in fiamme e la forza dell'aria lo sta premendo contro quella parte dell'abitacolo dal quale gli urge, invece, di staccarsi. Il paracadute vi si è agganciato e lui tenta disperatamente con le mani e con i piedi, mentre cade e gira col velivolo, di staccarsene; ma è trattenuto tenacemente Il caccia cade col muso verso terra, lui si sente bruciare i piedi mentre il colpo è scosso violentemente dagli ondeggiamenti della vite: per qualche strano e inesplicabile motivo gli balena in mente un complesso elettrico che aveva ideato: si tratta di una complicata. installazione che aveva previsto di fare a Audembert per la quale gli erano arrivati, proprio quella mattina, due motori nuovi di zecca; per alcuni istanti, in quei critici momenti, gli accade di fissarsi sul pensiero che non riuscirà mai a provarli. È davvero strano il meccanismo con il quale la mente umana lavora ! Scalcia disperatamente mentre con le mani si afferra all'antenna della radio e fa un ultimo, disperato sforzo per liberarsi: a un tratto, senza nemmeno riuscire a capire come mai vi sia riuscito, si ritrova nel vuoto, senza più impacci. È libero, precipita verso terra e rotola su se stesso mentre vi si avvicina rapidamente; con un senso di sollievo, ancorché sotto l'impressione del colpo subito, Gadland agguanta quella che crede debba essere la maniglia di apertura del paracadute e, appena in tempo, si rende conto trasalendo di quello che stava per fare: stava quasi per slacciarsi le cinghie mentre era ancora a mezz'aria. Se avesse azionato la Schnelltrennschloss sarebbe caduto liberamente, senza paracadute. Impressionato, agguanta con grande attenzione la maniglia di apertura (Aufreissgriff) e la tira; per un momento teme che il paracadute non funzioni poi, con un sobbalzo che lo mette in posizione quasi verticale e con i piedi verso il basso, la calotta si apre e lui si trova a oscillare avanti e indietro, dolcemente e senza rumore, mentre cala verso il suolo. È un tremendo contrasto con la disperazione e il terrore di qualche momento prima; è ancora abbastanza alto e, sotto di lui, i campi del colore di un bel verde estivo si allungano in tutte le direzioni. Si accorge che il suo Me 109, in fiamme, si sfascia al suolo a poco meno di un miglio di distanza e ripensa a quanto sia stato vicino anche lui a quella a fine. Poi uno Spitfire fa la sua comparsa svettando per il cielo; sembra che stia prendendo delle fotografie della sua discesa; altri caccia nemici sono più lontani e li sente sparare. Boulogne è chiaramente visibile verso occidente. Sta scendendo su una fitta foresta; il vento lo trascina proprio verso i suoi margini, ma non può prender terra in mezzo agli alberi... giù, giù! Il vento ve lo trascina contro, ormai vi si trova vicino e sta andando a finire esattamente contro una siepe. Un grande pioppo gli si viene a trovare proprio accanto; vi passa sotto, ma la calotta si va a impigliare nei rami e poi si abbatte al suolo mentre anche lui, non più sostenuto, sbatte a terra violentemente; sente soltanto un gran dolore all'anca sinistra. Per fortuna è caduto su una zona erbosa, umida e molle, altrimenti vi si sarebbe ferito in brutta maniera; ma anche cosi non si trova certo in buone condizioni. Fino a quel momento non si era reso conto di essere rimasto molto ustionato; adesso però che si trova disteso per terra perdendo sangue dalla testa e dal braccio destro e con un'anca slogata, bruciacchiato in tutta la parte inferiore del corpo, comincia ad accorgesi di come è ridotto. Fa uno sforzo per mettersi in piedi, ma non ci riesce: il fianco gli si sta gonfiando rapidamente e sente svanire le proprie energie; a mala pena può muoversi e, toccandosi, si accorge di avere delle schegge metalliche nella testa. Rimane sdraiato dove si trova, guardandosi attorno con uno sguardo appannato; nota, a una certa distanza, un contadino francese e poi un altro, che si avvicinano lentamente. Galland parla «Sono tedesco e sono ferito; per favore, aiutatemi». Tra quelli che lo circondano c'è una donna e tutti sono persone anziane; uno dice: «Morirà alla svelta, bisogna chiamare i tedeschi :se crepa prima che qualcuno arrivi a soccorrerlo diranno che siamo stati noi ad ammazzarlo ». Galland che ha capito quanto hanno detto esclama: «Ich werde nicht sterben. Ich bin sehr kraftig ». (Non morirò affatto, sono forte, io.) I francesi lo guardano sorpresi; qualcuno si china su di lui, poi si mettono a trasportarlo alla fattoria più vicina e, quando finalmente vi arrivano, il ferito chiede: « Haben Sie etwas Cognac?» In casa non hanno cognac: c'è soltanto un po' di acquavite in una bottiglia sporca, ma Galland ne beve ugualmente una lunga sorsata. Uno dei vecchi esce e va a cercare qualcuno dell’organizzazione Todt del lavoro: sono i tedeschi più vicini che vi siano. Dopo pochi minuti giunge un'automobile e, quando vede che sono dei connazionali, Galland si sente sollevato; questi domandano rapidamente: «Wohin sollen wir Sie bringen?» Il ferito risponde che vuole essere portato al suo aeroporto, ma quelli dicono che è meglio che vada all'ospedale; dato però che insiste tanto ,lo aiutano a montare in macchina e lo depositano al comando del 26° Stormo, a Audembert. Il suo arrivo causa eccitazione e sollievo; Galland riesce finalmente ad avere un cognac, un sigaro e comincia a sentirsi meglio. Poi i suoi uomini lo prendono su e lo trasportano al vicino ospedale della marina di Hardingham dove il suo buon amico, il dottor Heim, gli toglie alcune schegge dalla testa e comincia a rappezzarlo. Gli suggerisce di rimanere qualche giorno ricoverato, ma Galland si rifiuta di restare e, appena possibile, è di ritorno al suo comando: vuole mantenere il suo posto, anche se deve fare il comandante a terra. Lo stormo aveva denunciato quattordici abbattimenti, in tutta la giornata: una vittoria considerevole; Galland ha aggiunto tre vittorie e ne ha portato il totale a settanta. Nella stessa sera fu organizzata una specie di festicciola, proprio per far onore al bel risultato da lui conseguito: amici e ufficiali di grado elevato erano arrivati in volo per fargli festa e Galland vi partecipò tutto avvolto nelle bende. Venne anche il suo amico, generale Osterkamp, che giunse da Le Touquet con una sorpresa, poi confermata da un telegramma ufficiale proveniente dal quartier generale del Fuhrer. Il messaggio diceva: «lo conferisco a lei, primo ufficiale delle forze armate tedesche a ottenerle, le fronde di quercia con spade sulla Croce di cavaliere della Croce di ferro». Era firmato «Adolf Hitler». Cosi Galland fu il primo tedesco a ricevere quella decorazione: aveva già ricevuto .le fronde di quercia e, a quell'epoca, non si sapeva che vi sarebbero state, in seguito, altre decorazioni di guerra di valore superiore. Con quel telegramma era però arrivato un ordine: Galland non avrebbe più potuto partecipare ad azioni belliche senza la personale autorizzazione di Hitler. Questo gli tolse una buona parte del piacere che la serata gli aveva procurato. Tratto da : Sfide nei cieli
-
Adolf Galland Hans Joachim Marseille Erich Hartmann Lothar Lau Franz Schall Hermann Graf Walter Nowotny Hans Ulrich Rudel Sir Douglas Bader Stanford Tuck J.E. Johnson Pierre Clostermann Colin F. Gray Richard "Dick" Audet Hollis "Holly" Hills James "Ginger" Lacey R.S. Johnson Richard I. Bong D.W. Beeson "Bee" Charles Elwood "Chuck" Yeager Gregory "Pappy" Boyington Aleksandr Ivanovich Polkryshkin Ivan Nikitaevic Kozedub Lidija Litvak Constantin "B?zu" Cantacuzino Iyozo Fujita Hiroyoshi Nishizawa Sadamu Komachi Takeo Okumura Shigetoshi Kudo Toshiaki Honda Junichi Sasai Saburo Sakai Adriano Visconti Martino Aichner Luigi Gorrini Carlo Faggioni Furio Niclot Doglio Aldo Menzione Gino Brizzolari Vittorio Minguzzi Enrico Salvi Franco Bordoni Bisleri (Robur) Cap. Monti LUIGI CANEPPELE Tenente pilota Felice Fox Mag. P. Spadaccini Giorgio Graffer Col. Ernesto Botto Mag. Massimiliano Erasi Ten. Saieva Aldo Quarantotto e Carlo Seganti
-
....E difatti , in un paese CIVILE, questo non dovrebbe essere consentito..
-
Semplice!!!! Ogni paese ha il governo e le leggi che si merita!!!!!!!! Ora, dal momento che noi siamo un paese di Me@@a.... Ne consegue che…..
-
Sadako Si chiamava Sadako Sasaki e aveva quattordici anni. Il soffio dell'atomica giunse appena a sfiorarla quando non aveva che un anno di vita. Se riuscirò a costruire con le mie mani mille bianche ali di carta , diceva Sadako alle sue compagne, ripetendo le parole di un'antica leggenda giapponese , sono certa che non morirò. La sua esistenza finì prima che le mille ali bianche potessero prendere il volo. Oggi a Hiroshima, un monumento ricorda la storia di Sadako. E le bambine delle scuole costruiscono ghirlande di fragili ali di carta che vengono inviate in tutto il mondo, agli uomini politici, agli scienziati, ai capi di stato. Qualcuna di esse riesce a volare. Pagina conclusiva di : 6 Agosto Storia della bomba atomica
-
Nagasaki la vittima dimenticata I mille orrori di Hiroshima, la dichiarazione ufficiale del Governo degli Stati Uniti che la città è stata annientata dalla nuovissima e implacabile arma atomica, le agghiaccianti testimonianze sulla tragedia degli stessi inviati del Governo di Tokyo non sono bastati a smuovere la testarda ottusità della casta militare giapponese. Hiroshima è una landa deserta, ma il Giappone non mostra alcuna intenzione di arrendersi. A Tinian, base del 509° Gruppo , è già pronta la seconda bomba nucleare operativa. E' diversa da quella che ha distrutto Hiroshima, che aveva una carica di Uranio 235, ed è della stessa specie, invece, della bomba sperimentale fatta esplodere nel New Mexico il 16 luglio 1945: la carica atomica è al plutonio, un elemento transuranico, che non esiste in naturà. Ma la potenza distruttiva è pressappoco uguale, equivalendo in entrambi i casi a quella di 20.000 tonnellate di tritolo. Il generale Carl Spaatz, Comandante in Capo delle Forze Aeree Strategiche americane nel settore del Pacifico, ha l'ordine. di far lanciare su una città giapponese la seconda bomba. Alle 13 e 30 dell'8 agosto 1945, dall'isola di Guam, Spaatz invia a Tinian in cifrato, l'ordine di Operazione N. 39, relativo alla «Missione Speciale N. 16»: dice che l'obiettivo primario della bomba al plutonio è Kokura, l'obiettivo secondario è Nagasaki. Il cappio si stringe attorno al Giappone, quello stesso giorno entra in guerra anche l'Unione Sovietica. Il colonnello Tibbets, Comandante del 509° Gruppo Misto e pilota del B-29 « Enola Gay » che ha sganciato l'atomica all'uranio su Hiroshima, convoca gli equipaggi della « Missione Speciale N. 16» alle quattro del pomeriggio. Stavolta decolleranno da Tinian cinque B-29 invece di sei. Prima ne partiranno due che faranno da battistrada, cioè i ricognitori meteorologici: N. 91 del capitano Marquard, destinato a Kokura, e Straight Flush del maggiore Claude Eatherly, per Nagasaki. Mezz'ora dopo i ricognitori meteorologici, spiccherà il volo la Superfortezza che recherà l'atomica al plutonio, accompagnata da altri due B-29, incaricati rispettivamente di lanciare gli strumenti di registrazione dello scoppio sulla città bombardata e di compiere i rilievi fotografici. Il bombardiere vero e proprio è il Bock's Car e viene assegnato a Charles Sweeney. La bomba al plutonio si chiama Fat Man perché ha forma tondeggiante e panciuta. E' lunga 3 metri e 24, ha un diametro massimo di 1 metro e 35, pesa 4500 chilogrammi, è dipinta di giallo con le alette nere. Contrariamente a Little Boy, partirà su Bock's Car già innescata. A mezzanotte il colonnello Tibbets raduna nuovamente gli equipaggi per discutere gli ultimi dettagli. Tutto sembra procedere bene quando, nel pieno dei preparativi, si verifica un colpo di scena. Kuharek, il motorista di Sweeney, annuncia laconicamente: « Siamo nei guai! ». Una pompa ausiliaria di alimentazione non funziona, su Bock's Car. Ciò significa che il carburante di riserva resterà bloccato nei serbatoi, e l'aeroplano, appesantito da «Fat Man», non ne avrà a sufficienza per compiere la missione e tornare alla base di Tinian. Sweeney informa immediatamente Tibbets, Tibbets stringe i denti e dice, secco: «Decidi tu, Chuck!». E' un momento drammatico, perché la «Missione Speciale N. 16» non si può rinviare. Sweeney ci pensa un attimo, poi dichiara: « Vuol dire che, nel ritorno, atterrerò a Okinawa per rifornirmi» Alle 2,30 del 9 agosto decollano da Tinian i battistrada meteorologici, N. 91, e Straight Flush. Alle 2,56 partono Bock's Car, Great Artiste e il terzo B-29. Great Artiste trasporta una capsula speciale che sarà lanciata con gli strumenti di registrazione: contiene un accorato messaggio di un gruppo di scienziati atomici americani per un collega giapponese, il professor Sagane, affinché faccia udire la sua voce ,autorevole ai membri del Governo di Tokyo e li induca a porre fine a un massacro senza speranza. Inoltre Great Artiste reca un passeggero in più, il giornalista William L. Laurence del New Y ork Times, futuro Premio Pulitzer. Anche l'aereo fotografico del maggiore Hopkins ha a bordo due estranei, due inglesi. Sono il professor Penney, fisico atomico di Londra, e il colonnello Leonard Cheshire, il più famoso pilota di bombardieri della Royal Air Force, entrambi inviati straordinari di Churchill. Il Pacifico è in tempesta, soprattutto su Iwo Jima imperversa un autentico uragano. Le Superfortezze lo attraversano con qualche difficoltà, perché per il momento volano piuttosto basse. Presto spunta l'alba. Su Bock's Car, Kuharek non fa che controllare e ricontrollare il livello del carburante. E' preoccupatissimo. Alle 6 del mattino c'è un nuovo evento da cardiopalma. Fat Man dà segni di nervosismo, la luce rossa che fa da spia ai circuiti elettronici della bomba si accende all'improvviso. Ashworth,Bames e Beser si precipitano per scoprire cos'è che non va, e sanno che possono disintegrarsi da un momento all'altro. Due interruttori sono invertiti, per un incredibile errore di montaggio. Bock' s Car e i due B-29 che ronzano nella sua scia l'hanno scampata per miracolo. Gli aerei meteorologici raggiungono i loro obiettivi, Kokura e Nagasaki, verso le 8, ora giapponese. Da Kokura, Marquard fa trasmettere che il cielo è chiaro, ma ci sono venti forti al suolo. Da Nagasaki, Eatherly annuncia: «Cielo nebbioso, coperto per 2/8. Si prevede una rapida schiarita» Le condizioni atmosferische, invece, stanno evolvendo in modo opposto. E' in arrivo una burrasca dal Mar della Cina. Sull'isoletta di Yaku Shima è stato fissato l'appuntamento a vista fra Bock's Car, Great Artiste e l'aereo del maggiore Hopkins. Ma questo, andato alla deriva proprio nell'ultima ora di volo, non si vede. Sweeney è furibondo, per via di quella brutta faccenda del carburante che brucia goccia a goccia. Ma aspetta, girando in cerchio su Yaku Shima per quasi 45 minuti. Poi non può più indugiare. Abbassa il muso di Bock's Car in segno di intesa per Great Artiste. il silenzio-radio è di obbligo – e i due apparecchi, insieme, riprendono il volo verso Kokura, situata a nord della grande isola di Kyushu, non curandosi di Hopkins. Saranno raggiunti solo all'ultimo istante. Alle 9,50 Bock's Car è in vista dell'obiettivo primario. Il punto di mira è l'arsenale di Kokura. Tutta la città è coperta dalla nuvolaglia, ma Beahan riesce ugualmente a inquadrare, attraverso le lenti del dispositivo di puntamento, un grande deposito ferroviario; Ha studiato a perfezione la pianta topografica di Kokura e sa che l'arsenale non è distante. « Pronto per lo sgancio, comandante » annuncia a Sweeney. Ma un attimo dopo: «Maledizione! Le nubi! Non vedo piu niente! ».. La bomba è sulla corsia di lancio e gli uomini di Bock’s Car Bock's Car si sono già messi i polaroid che devono proteggere i loro occhi dal lampo dell'esplosione. «Facciamo un secondo passaggio», dice Sweeney. Bock's Car compie un ampio giro nel cielo a 9800 metri di quota, quindi torna sulla verticale di Kokura. La visibilità è sempre pessima. Terzo passaggio, con Beahan curvo sul congegno di mira, nervosissimo: lui, detto il «Grande Artista:. per la sua abilità di puntatore. Buio pesto al suolo. Sweeney e Ashworth decidono concor¬emente di lasciar perdere l'obiettivo primario e di attaccare quello di riserva: Nagasaki. Kokura se l'è cavata per un capello. Bock's Car vira a sinistra e punta a sud-ovest. Nagasaki non è un bersaglio ideale. Ha già subito cinque o sei attacchi aerei convenzionali, sia pure non molto pesanti e per di più ha una conformazione planimetrica assai accidentata. Nell'insieme, vista dall'alto, la città sembra una forchetta a due rebbi disuguali. il suo nome significa «Lunga Valle », in realtà l'abitato si stende su due valli quasi parallele, divise da una cresta collinosa al centro e circondate da altre colline. Nella valle più corta , la valle di Nakashima ,c'è la parte vecchia della città, densamente popolata. In quella più lunga , la valle di Urakami , sorge prevalentemente la zona industriale. Gli abitanti di Nagasaki sono circa 250.000. I punti di mira prefissati sono due, a scelta del puntatore secondo la visibilità: i cantieri Mitsubishi nel porto, oppure le fabbriche d'armi Mitsubishi in Urakami. Le sirene dell'allarme aereo suonano alle 10 e 53, quando già Bock's Car è sull'obiettivo con Great Artiste. L'ordine è di bombardare a vista, non a mezzo radar; ma bombardare a vista non si può perché le nuvole scorrono quasi senza interruzione sotto l'oculare di Beahan, che riesce a malapena a distinguere i contorni del porto. Sweeney e Ashworth risolvono di contravvenire agli ordini e di usare il radar: sempre e ancora per colpa del carburante che scarseggia in altre parole per il pericolo di dover compiere un ammaraggio di fortuna con la bomba innescata nel ventre di Bock's Car. E' questo che condanna Nagasaki! Il lancio strumentale è un problema dell'ufficiale di rotta Van Pelt e del radarista Buckley. Buckley controlla i punti di riferimento lungo la costa e Beahan segue la rotta di Van Pelt con il traguardo di mira. Malgrado ogni suo sforzo, non è in grado di individuare la posizione dei cantieri. Non importa. Punterà su quella, approssimata, delle fabbriche d'armi. ' Portelli di sgancio aperti, lieve correzione di rotta, calcolo automatico delle cordinate di lancio. Lunghi secondi di suspense, finché Beahan grida: «Bomba fuori » Sweeney costringe l'aereo , come già Tibbets ha fatto su Hiroshima , a una strettissima virata e a una vera e propria fuga. Sono.le 11,01 del 9 agosto 1945. La bomba impiega esattamente 52 secondi e mezzo per attraversare gli strati di aria, di densità variabile, che separano il punto di sgancio da quello di scoppio, a 450 metri d'altezza dal suolo. L'esplosione avviene per mezzo di un impulso elettronico. Nel momento in cui Fat Man s'è staccato dall'apparecchio, una speciale «Scatola Nera» di Beser ha cominciato a inviare a terra dei segnali, che sono rimbalzati uno per uno sulla bomba in caduta. Al diciannovesimo rimbalzo, come calcolato dagli scienziati, la reazione a catena: due blocchi di plutonio vengono proiettati l'uno contro l'altro dalle spolette esplosive e formano la «massa critica ». Lo scoppio di Fat Man è terrificante quanto quello di Little Boy a Hiroshima. Nessuna differenza. Un lampo troppo vivido per essere sopportato dalle pupille dei mortali, una istantanea emanazione di calore stellare, una onda di pressione che polverizza qualsiasi ostacolo su un'aera di tre-quattro chilometri quadrati dal punto zero e danneggia gravemente le altre opere dell'uomo su una superficie tripla, poi una impetuosa tempesta di fuoco che tutto arde e incenerisce, mentre una colonna di fumo, di vapore, di scorie radioattive, di detriti, rottami e spoglie di animali carbonizzati sale velocemente verso il cielo. Laurence, il giornalista imbarcato sul B-29 di Bock, scriverà: «Dalla cima della colonna si diramò un fungo gigantesco che raggiunse la folle altezza di sedicimila metri, un fungo che sembrava anche più vivo della colonna e ribolliva furiosamente in una bianca schiuma cremosa, come se vi si agitassero dentro migliaia di geyser. Sembrava scosso da una furia primordiale, simile a una creatura che tenti di divincolarsi dai ceppi che la tengono prigioniera. Quando ci apparve per l'ultima volta, aveva mutato forma: pareva un fiore, con i colossali petali rivolti verso il basso, di un bianco - panna all'esterno, color rosa all'interno. La colonna in ebollizione si era trasformata in una montagna di sovrapposti arcobaleni. Una notevole quantità di materia vivente era entrata in quegli arcobaleni ». Fat Man è esploso nella valle di Urakami, per fortuna la meno densamente popolata, in un punto equidistante fra le acciaierie Mitsubishi e le due fabbriche d'armi a Ohashi e a Morimachi. Ora la valle. di Urakami è un deserto di sabbia ardente. Le travi d'acciaio delle fabbriche appaiono piegate e contorte come se fossero di gelatina, i tetti degli edifici in cemento armato sfondati dal pugno tellurico della bomba, le case di legno e di carta letteralmente sparite. Meno devastata la città vecchia, che lo sperone roccioso fra le due valli ha protetto. I morti sono 60.000, forse, o 80.000. Altri morranno in un futuro prossimo e in un futuro più lontano, corrosi dalle radiazioni. Dopo l'orrore di Hiroshima, Nagasaki impressionerà assai meno la coscienza dell'umanità. Nagasaki sarà, subito, una vittima dimenticata, anzi la vittima dimenticata. Non perché ha pagato uno scotto un po' inferiore in termini di morti e di devastazione materiale: solo perché è venuta dopo Hiroshima. Ma l'orrore è stato uguale. L'onda d'urto che colpisce Bock's Car sedici secondi dopo l'esplosione, poi, è molto più forte di quella che ha squassato Enola Gay in allontanamento da Hiroshima. Anzi, qui le onde d'urto sono addirittura cinque, a causa della configurazione 0rografica del terreno su cui sorge , o meglio sorgeva, Nagasaki, e del conseguente gioco degli echi e dei rimbalzi. Bock's Car resiste alle sollecitazioni quasi per miracolo. Dopo, non c'è tempo per Sweeney di soffermarsi a osservare lo spettacolo della nuvola che sale dalla città atomizzata. Il carburante è agli sgoccioli, Kuharek ammonisce che bisogna ridurre la velocità di crociera se non si vuole cadere in mare. Spitzer invia un messaggio-radio a Tinian, che contiene una bugia: « Bombardata Nagasaki a vista. Nessuna azione da parte dei caccia e della contraerea. Effetti visibili quasi simili a quelli di Hiroshima. Noie a bordo in seguito al lancio ci obbligano a puntare su Okinawa. Carburante sufficiente per giungere solo a Okinawa ». Intanto un idrovolante con a bordo tre aviatori giapponesi, temerari quanto ingenui,il tenente Komatsu, il sottotenente Tomimura e il sergente Umeda, è decollato dallo scalo di Sasebo e si dirige dritto nell'inferno del fungo atomico. Komatsu vuole rendersi conto di persona della natura della nuova bomba, tanto decantata dagli americani. L'idro entra nel buio di pece della nuvola, che sta vertiginosamente salendo fino a ventimila metri, e ci resta per qualche minuto. Quando ne esce, i tre uomini sudano come se avessero fatto un opprimente bagno turco, hanno un mal di testa lancinante e una nausea atroce. Nessuno di loro si salverà dalle radiazioni, nelle quali si sono incautamente immersi. Alle ore 13 Bock's Car atterra a Okinawa con un motore fermo, sussultando. Gli sono rimasti da utilizzare 26 litri di benzina L’Atomica di Hiroshima , Mondadori 1972
-
Ma allora l'Awacs c'era ....
-
Con tutto il rispetto possibile,personalmente di poetico non ci trovo niente, ed eviterei, sempre se possibile, il ricorso ai faccini sorridenti. Probabilmente stiamo parlando dello stesso testo, del quale ho riportato titolo, casa editrice e data di pubblicazione. Se riesco a trovarla, pubblicherò l’assurda storia di un personaggio giapponese, miracolato ad Hiroshima e deceduto a Nagasaki… PS: Grazie Legolas . Non era mia intenzione mettere in discussione l’uso delle armi atomiche nel caso specifico, tra l’altro già oggetto di discussione in un altro topic,ma ricordare l’altra parte che troppo spesso viene invece dimenticata…
-
Si aprono i portelli di sgancio, con qualche cigolio. La bomba è sempre saldamente trattenuta dalle dita d'acciaio di quattro robuste tenaglie. Ma sotto, adesso, non c'è che lo spazio. Fino alla nuda terra. Ferebee si volge un attimo per lanciare uno sguardo a Tibbets, seduto dietro di lui, e lo assicura : - Tutto Ok -. Poi torna, fulmineo, al mirino. Il ponte non è ancora al centro della croce di mira, ma, poiché lo sgancio avverrà automaticamente, il puntamento a vista è stato anticipato di un minuto esatto. Diciassette secondi dopo le 8.14. Scocca il momento di Ferebee, ed egli preme istantaneamente il pulsante che sincronizza il lancio della bomba con il meccanismo d'innesco a tempo. Quaranticinque secondi trascorrono in un silenzio quasi allucinato, poi un sibilo lacerante risuona fra le pareti metalliche di Enola Gay. E' un segnale di Nelson, che annuncia agli altri componenti dell'equipaggio, a Great Artiste e a N. 91 che fra un quarto di minuto la bomba precipiterà su Hiroshima. Questo urlo sinistro è captato anche a terra, dalle radio giapponesi della difesa. Ufficiali e soldati si fissano l'un l'altro negli occhi, esterrefatti. C'è un B-San su Hiroshima, il segnale viene da lì. Cos'è? Perché? Ore otto, quindici primi, diciassette secondi. Il segnale cessa di colpo e Little Boy si stacca da Enola Gay. Per 51 secondi sarà solo un grave in caduta. Eccolo! Trascinato in avanti dalla forza d'inerzia ,nell'istante dello sgancio Enola Gay filava nel cielo a una velocità di 147 metri al secondo ,. sembra voglia seguire l'aereo-madre, ma presto assume un’ assetto diverso, la punta tende verso il basso, la coda pinnata si solleva, e la gravità ha ragione della spinta inerziale. Sgravata all'improvviso da un peso di quasi quattro tonnellate e mezzo, Enola Gay ha compiuto intanto uno spettacolare balzo verso l'alto. Tibbets ha immediatamente escluso il pilota automatico e, le mascelle contratte, s'è letteralmente gettato addosso alla cloche per far acquistare la massima velocità possibile all'apparecchio con un principio di picchiata, al limite del rischio per un quadrimotore. Contemporaneamente le ali sembrano schiantarsi, la sollecitazione della virata a 180 gradi è tormentosa. Gli uomini si sentono schiacciare, ma non ci badano, guardano giù lo stesso e non sanno neppur essi se sono atterriti, affascinati o scettici. Potrebbe essere un bluff, dopo tutto. Ma no, sono sgomenti, qualcosa dice che sta per accadere l'inimmaginabile. All'improvviso esplode una luce insostenibile Da Great Artiste scendono pigramente tre paracadute che reggono gli strumenti di registrazione. Su N. 91 le cineprese sono già in attività. A Hiroshima, sulle piazzuole delle batterie contraetee, che tacciono, ufficiali e sottufficiali hanno seguito con i binocoli le bizzarre evoluzioni del B-San: un vistoso salto in verticale, poi una picchiata degna di un bombardiere leggero e una virata inconcepibile. Sono impazziti gli yankees, questa mattina? Little Boy sta precipitando e la sua traiettoria tende sempre più alla verticale, la velocità di caduta aumenta progressivamente obbedendo alla legge dell'accelerazione di gravità. Enola Gay fugge con tutta la potenza dei suoi motori. A Hiroshima si lavora, si parla, si ride. - Ma perché non scoppia? - urla Morris Jeppson che ha contato troppo affrettatamente i secondi previsti fra lo sgancio e la deflagrazione. Ore otto, sedici primi, otto secondi. I detonatori proiettano l'uno contro l'altro i quattro blocchi di Uranio 235. Si forma la massa critica, e all'istante Little Boy si disintegra: un nuovo sole artificiale, provocato dall'uomo, s'accende sulla Terra. Un globo di luce intollerabile per le pupille degli uomini e degli animali terrestri, una emanazione di calore cinquemila volte più intensa di quella di una fiamma ossidrica che sprizzasse le sue scintille in un raggio di duemila metri, un pugno apocalittico sferrato dal cielo alla terra. La pura dissoluzione della materia, nel delirio psichedelico di un mondo extra-galattico. Centro focale della follia degli atomi, un punto nell'atmosfera situato a poco meno di 600 metri di altezza sul piano stradale della città di Hiroshima, Giappone, e 190 metri a nord-est dal ponte sul fiume Ota prescelto come bersaglio. I calcoli degli scienziati e degli ingegneri sono stati maledettamente esatti. Ora la luce è ovunque. Una luce accecante, di ghiaccio, che in un attimo di attimo lo spettroscopio del cielo scinde in tutti i colori dell'iride . Si espande fino ai limiti dei quartieri periferici e pare un ciclopico globo di magnesio, frangiato di rosa e di porpora. Fin dal primo attimo 30.000 uomini dissolti nel nulla In quest' attimo di attimo muoiono forse 30.000 persone. Muoiono? Finiscono di esistere, non solo come esseri umani, ma come entità materiali. I loro agglomerati di cellule, in taluni casi le loro stesse strutture molecolari, svaniscono nel nulla assoluto. Nessuna sensazione, nessuna sofferenza. Niente. Uomini, animali, alberi, foglie, tutto ciò che c'è di organico a Hiroshima e che è sorpreso all'aperto in un raggio di mille metri dall'epicentro del pikadon – in giapponese, il «lampo-tuono» della bomba atomica - si volatilizza come un etere cosmico. Il pikadon, in quella frazione di istante, schiarisce la corteccia esterna di tutte le sostanze resistenti che investe, come il granito. Su quelle superfici, comuni in qualsiasi città dell'Oriente e dell'Occidente, i dissolti vivi lasciano impresse indelebilmente le loro ombre. Ombre di uomini giovani e di uomini vecchi, di donne, di bambini, di cavalli, di cani, di polli, di mosche, di farfalle, di fiori. Ombre di spettri. Qui , entro un'area di 3-4 chilometri quadrati , c'è la fine dell'essenza intima di ogni cosa. Ecco uno zoccolo di basalto, presso il vetusto tempio di Gokoku. Sembra, adesso, un puntaspilli, perché è irto di migliaia di acutissimi aghi. Sono cristalli mai visti, nati dalla fusione dello zoccolo. Per un tempo non misurabile, ma dell'ordine di 1/10.000 o di 1/20.000 di secondo, il bagliore del pikadon lo ha raggiunto con la sua lingua di fuoco da 300-500.000 gradi. I dissolti vivi sono di gran lunga i più fortunati, alle ore otto, sedici primi e otto secondi di questa mattina, a Hiroshima. C'è poi un'altra specie di uomini quasi altrettanto fortunata nella inverosimile sciagura. Questa, che si può definire la specie degli uomini-formica, in opposizione alla precedente specie di uomini-ombra, non svanisce in una frazione di istante, ma muore - ecco, muore: è già più umano, più nell'ordine naturale delle cose - in due, tre, cinque secondi, massimo sette. Mai visto , magari attraverso una lente , come muore una formica abbrustolita? Lambito e avvolto dalla fiamma, il piccolo e laborioso insetto nero si rattrappisce, si contrae, rimpicciolisce, crepita, scoppietta, incenerisce, diventa fumo e poi zero. Ecco, questa è la sorte di coloro che sono all'aperto in una fascia compresa fra i mille e i duemila - duemilacinquecento metri dallo l'epicentro dell'esplosione. Anch'essi sono lambiti dall'alito rovente del pikadon per un tempo infinitesimale, ma è un alito già un po' meno rovente. Chissà se s'accorgono di diventare cenere, due-sette secondi possono essere un'eternità. Comunque soffrono obiettivamente per poco. Non conosceranno il massimo dell'orrore. Se qualcuno si rende conto di quanto di inconcepibile gli capita, non ha il tempo di maledire. Quanti sono gli uomini-formica? Sommati agli uomini-ombra , in totale sono 80.000 gli abitanti di Hiroshima che rendono lo spirito a Budda o agli dei dello Shinto entro sette secondi dallo scoppio di Little Boy. Ma il primo e il secondo girone dell'inferno atomico non hanno contorni perimetrali cosi esatti. Anche a poche centinaia di metri dal punto focale dell'emissione di luce ci sono gli sventuratissimi, destinati alle sofferenze più folli come quelli che se ne trovavano relativamente lontani. Essere al coperto ma vicini, nel momento in cui si attiva la luce astrale del pikadon, equivale a essere esposti ma distanti, oltre i margini del secondo cerchio infernale, che ha un diametro approssimativo di cinque chilometri. Dopo lo scoppio , una ventata immane spazza ogni cosa Qui l'atrocità più assurda che la storia e la preistoria del pianeta Terra abbiano mai visto si svolge in una convulsione di sequenze e dissolvenze da teatro-verità agghiacciante, mostruoso, delirante. Siamo oltre i limiti del credibile, tanto per il cervello, il cuore e i nervi degli uomini normali quanto per le menti malate dei pazzi. Ed è un'atrocità che è tale proprio perché non dura una frazione di istante, né due-sette secondi. Dura minuti, ore, giorni, settimane. Può durare mesi e anni. Per qualcuno, nel 1972, non è ancora finita. Ma restiamo a quel tragico mattino. Il soffio del pikadon, al di là del circolo di due chilometri e mezzo di raggio dall'epicentro dello scoppio, arriva sensibilmente attenuato. Non ha più una temperatura stellare, e perciò gli manca l'energia termica sufficiente a volatilizzare gli esseri viventi e ad incancrenire gli aggregati delle sostanze dure. E' però pur sempre rovente, e la sinistra vampa è pregna di letali particelle radioattive, i raggi gamma: almeno 90.000 abitanti di Hiroshima diventano uomini-carbone, uomini-mummia o uomini-cera. Altre tre specie subumane create da Little Boy. Uomini-carbone, ustionati cosi sconciamente da apparire simili a protoantropi nerastri, o addirittura a scimmie primordiali, di un'altra Età del mondo. Uomini-mummia, legnosi e rinsecchiti, con gli abiti calcificati addosso, proprio come le bende delle mummie. Uomini-cera, a tal punto piagati da vedersi sciogliere mollemente le carni, fino al biancheggiare delle ossa. Come la bomba atomica esplode, Hiroshima è percossa da un colpo di maglio gigantesco. Il centro della città è spazzato in un sol colpo; polverizzato dall'immane pressione. Reggono per puro caso, qua e là, pochi muri e poche travi. Masse di terra strappate perfino al sottosuolo, rottami, detriti, pezzi di corpi carbonizzati sono risucchiati verso l'alto e salgono vorticosamente verso la stratosfera nella colossale colonna di vapore, fumo e polvere che lo scoppio ha generato. E' una colonna candida, attraversata da bagliori vulcanici. Scurisce man mano che s'inerpica nel cielo. In 48 secondi arriva a 3000 metri e già assomiglia a un curioso fungo perché, in cima, s'è dilatata. In 3 minuti è a quota 9000. Salirà gradualmente, sempre più sfaldandosi, fino al tetto vertiginoso di 17 chilometri. Hiroshima è come un lago di magma ardente, sul quale il sole non splende più; la nube a forma di fungo lo ha completamente offuscato. E' scesa la notte atomica. Dopo il pikadon, il vento: una tempesta d'aria surriscaldata che imperversa sulle rovine alla velocità fantastica di 800 km/h, quattro volte maggiore di quella del più violento ciclone. Ciò che non è crollato immediatamente, sotto la spallata tellurica dell'esplosione, si sfascia adesso nel turbinare pazzo di questo tornado senza precedenti. Una polvere sabbiosa, minutissima; flagella Hiroshima da un capo all'altro. Anche a 3 chilometri dal punto dov'è ,esploso Little Boy i pali del telegrafo si sono anneriti nella parte esposta al lampo. Ma nemmeno i pali sono abbastanza sottili per sopportare la ventata ciclonica. Si salvano solo gli oggetti filiformi, che offrono una resistenza irrilevante. La pressione e il calore hanno già devastato 12 chilometri quadrati dell'area urbana di Hiroshima. Sono saltate tutte le tubazioni sotterranee, le centrali elettriche e del gas. Le acque del fiume Ota e dei canali, zeppe di cadaveri. L'uragano non accenna a placarsi, e già s'annuncia una nuova calamità. Folli di terrore, decine di migliaia di larve che hanno solo vaghe sembianze umane - le loro membra sono piagate, bruciate, dilaniate, talvolta squarciate in modo osceno, molti sono ciechi, tutti talmente annichiliti dall'orrore che quasi non percepiscono il dolore fisico - vedono scendere una pioggia fangosa, squallida, le cui gocce sono grosse come uova di piccione. Non è l'acqua, fonte prima della vita, che cade dal cielo sulla Terra. Il cielo di Hiroshima è maledetto, quest'acqua divora e corrode tutto ciò che tocca. E' la pioggia di scorie radioattive, e cala come un triste sudario liquido. E' accaduto che la naturale umidità atmosferica s'è vaporizzata nella sfera di fuoco, condensandosi poi nella nube a forma di fungo. Alla prima sventagliata di raggi gamma s'aggiunge ora una più copiosa colata di sostanze altrettanto malefiche, capaci di ulcerare e avvelenare i tessuti organici, il sangue, il midollo delle ossa, e di dare una morte lenta - o lentissima - ai già stravolti sopravvissuti. Non basta ancora. Arriva il secondo vento che, a differenza del primo, affluisce sui rottami della città dall'estrema periferia, anzi, dalla campagna e dal mare. Nell'enormità della catastrofe, è questo l'unico fenomeno non specificamente tipico dell'esplosione nucleare. Per primi lo hanno conosciuto gli abitanti di Amburgo nella notte del 28 luglio 1943, mezz'ora dopo la fine di un duro bombardamento aereo convenzionale, e subito lo hanno battezzato Feuersturm, tempesta di fuoco. Anche Tokyo, quando è stata attaccata da centinaia di B-San, ha vissuto una tragedia dello stesso genere, causata da un fenomeno fisico elementare. Una forte emissione di calore provoca la rarefazione delle masse d'aria circostanti, e questo vuoto relativo attrae le correnti dall'esterno. Ma le correnti, fatalmente, alimentano la fonte di calore, che così attrae altre correnti. La tempesta di fuoco non si placa che quando tutto è combusto. Il secondo vento non corre a 800 km all'ora come il primo, si accontenta di ringhiare a 250. Ma è un vento infuocato, tesissimo e turbinoso al tempo stesso, che sradica gli alberi anche a molti chilometri di distanza e li proietta come stecchini in quella sterminata fornace che è ormai Hiroshima. Con gli alberi, finiscono nella caldaia uomini e animali, a migliaia, magari rimasti fortunosamente incolumi fino a un minuto prima. Nei canali si sollevano onde altissime e molti sventurati, alla lettera, vengono bolliti vivi. Su Enola Gay non si è osservato nulla di tutto questo e non lo si è neppure immaginato, perché ciò che è avvenuto ha trasceso la più parossistica immaginazione umana. L’Atomica di Hiroshima , Mondadori 1972
-
Io e l’Effe (2° Parte) Quel giorno di Ferragosto ero di Strip Alert con il mio gregario di coppia, un giovanissimo sergente pilota. Sulle spiagge, appena fuori della base, le vacanze impazzavano; gli avieri in libera uscita si spacciavano per piloti da caccia e mietevano cuori di bionde nordiche in vacanza a Rimini. Noi due, chiusi dentro i paludamenti della sottomuta di lana e della tuta anti-G, si boccheggiava sfogliando riviste, all'ombra dei due Effe argentati in allestimento "pulito"; senza piloni né carichi esterni e con poco carburante per salire bene. Quel giorno eravamo noi gli intercettori. La Strip (decollo in tre minuti) era un servizio di allarme d'intercettazione assegnato a rotazione ai vari Gruppi per tener d'occhio il vicino confine dello spazio aereo dell'Est, in quegli anni di guerra fredda. “Scramble!" - gridò il maresciallo, correndo trafelato fuori dalla baracca. Partenza su allarme! "Via le spine di sicurezza" ordinò agli armieri. "Maresciallo, ma è sicuro? C'è conferma?" chiesi,mentre mi sistemavo in fretta tuta,paracadute,casco e tutte le imbracature. "Il Radar della DAT (Difesa Aerea Territoriale) ha detto chiaro: decollo armato immediato" rispose secco. Pensai a una bella esercitazione di Ferragosto. La Torre, al primo contatto , mi raggelò: "Prua 070° dopo il decollo, massimo rateo di salita per intercettazione reale ad alta quota.., cambiare con il Radar: canale 4- IFF on” Decollammo in un baleno, ala contro ala. Il radar ci prese subito sotto guida e ci chiese uno stimato per i 30.000 piedi. Roba da 5 minuti, a spinta di salita militare (98 per cento). "Due tracce, alta velocità, rotta 245, distanza 62" avvertì il controllore. "Oh, lalà” pensai. "Questo non è il solito Dakota o Constellation". Mentre salivamo, per rompere la tensione dissi per radio al gregario: "Non saremo mica noi due a far scoppiare la terza guerra mondiale!..." . Perché era chiaro che le tracce che stavamo per intercettare erano due caccia dell'Est che venivano, proprio di Ferragosto a saggiare la risposta della nostra difesa aerea. Un ballon d'essai, molto probabilmente. Però anche quella volta a Pearl Harbour era un quieto giorno festivo... "Flash 4 (il mio nominativo radio), qui Radar, target ore 11, 34 miglia " Eravamo addestrati a fare questo e lo stavamo semplicemente facendo. Riscaldamento armi" su "heater", selettore GBR su "Guns", Radar Range Max, Collimatore prova immagine e aggancio, arroccare sulla manetta... Stavamo dunque andando davvero al combattimènto? "Flash 4, qui radar, missione interrotta. Fermate la salita, fate un "180" (inversione di rotta), prua 250° per rientro". Mentre facevo il read-back (rilettura del messaggio per conferma), nel cielo davanti a noi, due scie bianche , due graffi di ghiaccio nel cielo limpido , avevano già fatto un ricciolo; richiudendosi su se stesse. Il nostro nemico invisibile era tornato a casa: era stata una provocazione. Solo allora mi accorsi di quanto ero sudato. Ce ne tornammo giù come meteore: sorvolo della pista a 400 Kts, apertura a sinistra,io per primo poi a tre secondi il gregario (mille-uno; mille-due; mille-tre) Flap, carrello, virata continua, tutto ftap. Il finale venne fuori veloce. "Diavolo, qui mi ci vuole il parafreno e magari la barriera" - pensai. "Gina-gina-gina". Era la chiamata per far scattare la barriera d'arresto a fine pista, una robusta rete di nylon. Ma l'aereo, in versione intercettore, era leggero, e mi fermai ugualmente con un bel margine. Il gran volare moltiplicava gli episodi belli, ma anche brutti. Con Giancarlo, mio compagno di corso, gregario della prima coppia, la nostra vickers di F 84F (due coppie formanti una V) raggiunse il poligono di tiro aria-terra in perfetto orario e, trasformatasi in ala destra (quattro aerei disposti in diagonale) iniziò subito l'attaccò. "Uno in!". Il leader della prima coppia,aprì a sinistra e si avventò con le sue bombe sui bersagli con un bell'angolo di 40 gradi. Seguì Giancarlo, poi io e, ultimo il mio gregario. Il carosello era subito entrato in pieno svolgimento. "Armare i razzi" ordinò il leader, iniziando il secondo passaggio e via di nuovo, uno dietro l'altro nella giostra che, dentro i tettucci di plexiglas era silenziosa e ovattata, mentre fuori l'inferno dei jet e i boati delle esplosioni metteva a dura prova gli osservatori a terra, blindati nei loro bunker in mezzo a quell'uragano. Stabilizzare con calma il pipper del collimatore; andare giù abbastanza per la precisione, ma tirare via in tempo; senza incantarsi sull'obiettivo; caso mai fare il passaggio "in bianco”. Queste erano alcune delle regole e procedure che dovevano essere curate per avere sicurezza e risultati. Al terzo round toccava alle mitragliatrici. Ormai era un unico circo: la formazione si chiudeva su se stessa in un treno continuo. Dal sottovento..mi attrasse di colpo l'attenzione uno dei velivoli: aveva un' angolo di picchiata esagerato (aveva aperto troppo presto?) e indugiava a correggere la traiettoria o andare via. Non sparava, né accennava ad alcuna manovra. In una frazione di secondo mi resi conto che Giancarlo si era incantato a stabilizzare il pipper. “Tira su! Tira su, Giancarlo!" gridai nella radio, sperando in Dio che ce la facesse. Già mi aspettavo una fine catastrofica in una palla di fuoco. Ma ecco che l'aereo cambiò bruscamente l’ assetto , anche se non molto la traiettoria per l’inerzia del bestione. Con il muso in aria e la coda quasi in terra, l'Effe spazzò con il getto al massimo una lunga striscia del poligono, facendo volare i tabelloni e le strutture dei bersagli. Finalmente, dietro a tutto quel polverone da lui provocato, vidi brillare le ali argentee in salita: Giancarlo poteva dire di essere nato una seconda volta. Un altra volta toccò a me. Durante una navigaziome notturna in coppia, gregario attaccato all’ala del numero uno. Entrati in un esteso banco di cirri a 35.000 piedi, il mio leader aveva dimenticato le luci di posizione su "intermittenti", invece che "fisse". Il manuale di volo era esplicito a questo proposito: "Il flashing periodico delle luci in nube diffusa può creare illusioni sensoriali" diceva. Dopo un poco, infatti, ebbi la sensazione , anzi la certezza , di essere in volo rovescio "Antonio, guarda che mi sento rovescio" dissi al mio compagno "Ma che dici rispose " Guarda l'orizzonnte artificiale” "È diritto, d'accordo, ma io ho questa sensazione fortissima" "Allora guardati la catenella (la piastrina militare di riconoscimento portataal collo): è dritta o penzoloni?.., por*a miseria, le luci 'blinkano !" esclamò subito dopo. Si era accorto dell'anomalia e mise subito le luci su "steady". Ciononostante, io continuai a volare come se fossi in coppia rovescia. Mi obbligai a tenere duro, anzi mi affezionai quasi, a questa illusoria posizione. Cosicché, quando uscimmo di nuovo in aria chiara, rivedere le stelle in alto e la terra sotto, fu per me.una forte sorpresa ,quasi una delusione. Un'altra volta, ritornando dai tifi aria-aria. al poligono di Brindisi, incrociammo (ma che caso!) una vickers di F 84F della rivale 6° Aerobrigata di Ghedi, che invece era in "andata" ln un baleno, si scatenò un arruffato finto combattimento con otto aerei che piombavano uno addosso all’altro e scomparivano subito nel nulla, come un frenetico attacco di squali. lo dovevo stare attaccato al mio capo-coppia, ma lui tirava tanti di quei G in tutte le direzioni che la formazione esplose ben presto e il carosello si fece individuale e caotico. Se fosse stato un combattimento vero, non sarei riuscito a mettere a segno neanche un colpo e così penso dei miei compagni e dei miei avversari. Allora compresi meglio quei racconti dei piloti di guerra, che descrivevano caroselli "in bianco" di questo tipo, nei quali era veramente arduo colpire; quasi un eccezione. Poi c’erano le "manfrine". Lo spettacolo più bello era il volo di massa per la.parata aerea del 4 Novembre: un pattugliane di decine di aerei, saldati tra di loro (pur con un certo trambusto) per sorvolare i Fori Imperiali della capitale. Ma ancora più bello fu il lavoro di preparazione della pattuglia acrobatica del 1960, i Getti Tonanti del 5° Stormo: Francesco Picasso, Mauro Ciceroni, Gianni Orlando,Sergio Capaccioli, Gregorio Baschirotto ed Enzo Villani. lo non potevo certo sperare di essere selezionato, fresco com'ero di reparto. Ma mi godetti per mesi uno spettacolo indimenticabile. Poi venne l'addio, alla fine della lunga e bellissima ferma di Complemento. L’ attrazione fatale delle linee aeree dell'Alitalia, mi portò via da quelle ali argentate, che oggi ricordo con nostalgia. Fu la più dolorosa e la più triste separazione .della mia vita.' Anche perché dentro l' Effe sapevo che avrei lasciato la spensierata audacia della giovinezza. Volare , Aprile 1997
-
Reparto Alta Velocità - Armando Palanca Coppa Schneider e primati mondiali di velocità 1928/1934 Ufficio Storico A.M. . Roma, 1996 . pp. 110 mai in passato era stato possibile, per il grande pubblico, leggere gli appunti personali di un protagonista di quelle epiche imprese. Il protagonista è Armando Palanca, un nome forse sconosciuto ai più, ma intimamente legato alle vicende del Reparto Alta Velocità di Desenzano. Per quanto giovanissimo, Palanca fu infatti chiamato a far parte del "team" di quel leggendario tenente colonnello Bernasconi che immediatamente aveva intuito le capacità professionali del fino ad allora anonimo aviere scelto motorista dell' 8° Gruppo Caccia. E c'è da dire che Palanca non deluse le aspettative del suo comandante divenendo ben presto una figura chiave per la preparazione e la messa a punto, purtroppo non indolore, del motore AS.6 da 3.200 CV (un vero "mostro" per l'epoca) che avrebbe portato al trionfo mondiale Francesco Agello e il Macchi Castoldi MC.72. Sempre in campo motoristico Palanca operò con il Centro Studi ed Esperienze di Guidonia e quindi con la compagnia LATI (Linee Aeree Transcontinentali Italiane). Durante la guerra, vestiti i gradi da tenente della Regia Aeronautica, Palanca lavorò sui grandi plurimotori a lungo raggio, aeromobili che lo videro impegnato anche negli anni successivi, dapprima presso la LATI e quindi con l'Alitalia. Con i turbofan dei Boeing 747 della compagnia di bandiera l' ingegner Palanca coronò degnamente un 'invidiabile carriera che l'aveva visto muovere i primi passi molti anni prima con una brillante modifica ai carburatori dei Fiat CR.1. Recentemente l'ingegner Palanca ci ha lasciati, ma chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ne ricorderà sicuramente la simpatia, la grande passione per il proprio lavoro e l'inconfondibile modo di fare, da eterno ed inguaribile ventenne. Sentendolo parlare delle ultime novità in campo aerospaziale si stentava a credere che "anagraficamente" avesse potuto lavorare intorno alla "raffica rossa". E Palanca, invece, vi aveva lavorato, eccome. E non solo: di tutto aveva puntualmente preso nota, riportando di proprio pugno eventi, circostanze, esperienze, personaggi. Proprio partendo da alcuni appunti di Palanca, l'Ufficio Storico dell'A.M. ha proposto questo volume che nel suo genere presenta l'originale caratteristica di essere stato realizzato anastaticamente nell' autentica grafia dell' autore. Certamente molti degli eventi citati o ai quali Palanca fa riferimento, fanno già parte della storia dell'aviazione e non avevano probabilmente bisogno di questa opera per essere ulteriormente illustrati essi sono tuttavia una cornice indispensabile per i veri contenuti di questo volume, ovvero le osservazioni di prima mano, gli appunti, le valutazioni tecniche ma anche gli stati d'animo che, con uno stile fresco e "asciutto", Palanca ci ha saputo trasmettere. Sulla scelta della stampa anastatica qualcuno avrà probabilmente osservazioni da fare, ma a nostro modesto parere un fatto è certo; leggere la chiara grafia di Palanca, tracciata nel perfetto stile dell'epoca, è come ascoltare un racconto virtuale dell'autore che ci aiuta a calarci nella realtà di quegli anni e rivivere imprese che tanto peso hanno avuto nella storia aeronautica del nostro Paese. E non è poco... Recensione Rivista Aeronautica
-
Fa niente!!! Alla prima occasione, mi dimenticherò di allacciarti le cinture e di farti indossare il paracadute... Cosi poi, mi dici come ci si sente in volo rovescio!!! Ciao PS: Aggiungo … L’incapacità a tenere l’aereo dritto deriva dal fatto che ho conseguito il brevetto di pilota privato per corrispondenza.. E conoscendo l’efficienza delle poste italiane, qualche dispensa vedi fondamenti di volo livellato, non sono mai pervenute. Anzi ne approfitto: Se qualcuno avesse mai ricevuto, per sbaglio, le mie dispense,, magari!!!!!
-
Contano anche quelli che non riescono a tenere dritto l'aereo per più di 10 sec. PS: la splendida macchina della foto è il cap10C di Ravenna!!!! Ciao!
-
Approfitto per aggiungere un piccolo dettaglio. Nella maggior parte dei casi, appena l’aereo ha toccato terra, il pilota smette di litigare con il vento è può rilassarsi. Non con una macchina Acro. In questo caso il pilota continua a litigare con il vento fino al parcheggio. In caso di vento forte in coda, durante un backtrack, la possibilità di mettere l’aereo in piedi (alzare la coda e urtare con l’elica a terra) è altissima. Difatti le procedure di rullaggio con vento, implicano il posizionamento dei comandi in modo opportuno, proprio per evitare una simile circostanza. Tipo:
-
Infatti avevo precisato che potevo non aver compreso bene il tema. Comunque, come ripeteva il nostro istruttore, le compagnie nella pianificazione del volo tengono conto della velocità dei jet stream che possono essere incontrati in quota. L’ultima volta che sono andato a Bangkok (747 KLM), all’andata la GS mostrata dall’indicatore video indicava 1080km/h / al ritorno non ha mai superato 890 km/h. A pari velocità IAS, sicuramente la GS risente della direzione del vento. Per quanto riguarda, l’acrobazia , posso garantirti che ti accorgi del vento laterale perché noti le variazioni di traettoria e del vento frontale/posteriore perché noti, rispetto al suolo, che l’aereo si muove più o meno velocemente a pari velocità indicata. E’ a questo che mi riferivo circa l’ininfluenza del vento a livello aerodinamico. Tieni presente le escursioni di velocità che ottieni su certe figure, e capirai come una componente di vento di 15 / 20 Kts dovrebbe essere altamente influente. Pensa al fiesler che lo ruoti a 60Km/h (circa 30 Kts) Per quanto riguarda l’atterraggio, gli effetti del vento diventano più imprevedibili perché spesso l’orografia del terreno o la presenza di alberi o edifici genera dei rotori. Spesso si decide di scendere un poco più veloci proprio perché, la GS rimane compatibile con la lunghezza della pista, e con la massima velocità consentita per l'atterraggio. Per il Decollo, il vento a raffiche è la situazione più complicata da gestire. PS: comunque, nella discussione da tem riportata si fa riferimento a decollo / atterraggio con vento a raffica. io mi riferivo a vento costante in volo
-
Ragazzi, ho la vaga sensazione che stiamo facendo un pochino di confusione. (però potrei aver capito male io ed in questo caso chiedo scusa) Probabilmente perché, consideriamo il vento come un elemento perturbativo della massa d’aria quiete nella quale si muove l’aeroplano, o se preferito aggrappato alla quale vola l’aeroplano. In realtà, il vento è la stessa massa d’aria nella quale si muove l’aereo, rispetto alla quale ha bisogno di mantenere una velocità relativa per poter sviluppare portanza. Ergo, aerodinamicamente parlando, il vento è assolutamente ininfluente per quanto riguarda il comportamento aerodinamico. Ciò che cambia sensibilmente, sono i parametri (direzione e velocità) riferiti al suolo. Semplificando il concetto, Il vento in coda aumenta la ground speed dell’aero rispetto alla Indicated Air speed che rimane identica all’aria quiete. Provate ad immaginare di eseguire un fiesler in aria calma o con una componente al traverso di 20 Kts. (ehm ! facciamo 15 Kts, altrimenti l’atterraggio sarà un po’ difficile da farsi con un 10C) Che cosa cambia nell’esecuzione della manovra ? Assolutamente niente!!! Solamente che se avete iniziato la manovra in asse con la pista, quando la chiudete noterete che siete traslati nella stessa direzione del vento! Perchè state volando in una massa d'aria che si sposta rispetto al suolo. E questo purtroppo lo noteranno anche i giudici di gara. Quindi l’unico accorgimento da adottare, sarà quello di salire leggermente storti per compensare lo scarrocciamento dovuto al vento!!! quindi compensate solamente la traettoria, e non l’esecuzione della manovra i cui parametri rimarranno assolutamente identici.
-
Una delle più grandi aspirazioni della Germania, attraverso i secoli, è sempre stata quella di poter competere sul mare con l'Inghilterra. Questa ambizione che nascondeva l'inconfessato desiderio di sostituirsi alla Gran Bretagna nel dominio dei mari e quindi di poter essere la prima potenza mondiale, non poté essere soddisfatta né dalla Marina imperiale del Kaiser Guglielmo II, né successivamente dalla Kriegsmarine" del terzo Reich. Il trattato di Versailles aveva fortemente limitato sia il numero delle navi da guerra germaniche, sia il loro tonnellaggio; per i tedeschi fu, quindi, necessario studiare nuovi tipi di costruzioni che, pur restando nei termini imposti dal trattato, dessero alla "Kriegsmarine" il massimo della potenza. Nacquero, così, nei cantieri germanici quei piccoli gioielli della tecnica navale che furono le corazzate "tascabili". Navi che avevano, però, anche i loro limiti, focalizzati proprio nella necessità che era stata alla base della loro concezione. Infatti, per guadagnare tonnellaggio a favore delle artiglierie (cannoni da 280 millimetri), erano state sacrificate nella potenza con l'installazione di numerosi motori "Diesel", in luogo delle turbine (velocità massima 26 nodi). Ma, malgrado l'entrata in servizio di queste validissime unità, la Germania, allo scoppio del secondo conflitto mondiale, non era in grado di affrontare apertamente in battaglia la flotta inglese. Dovette, perciò, ricorrere ancora una volta alla guerra di corsa: le antiche glorie degli incrociatori fantasma "Emden" e "Wolf" e di tanti altri dovevano rivivere con i nuovi corsari che avrebbero causato seri danni ai traffici marittimi alleati sotto tutte le latitudini. Prescindendo dalle fortunate imprese dei mercantili trasformati per la guerra di corsa quali il "Pinguin", il "Kormoran", l'''Atlantis", il "Komet" e decine di altri e tralasciando la tragica crociera della corazzata tascabile "Graf Spee", autoaffondatasi nella battaglia del Rio della Plata, l'episodio saliente di questo tipo di guerra sul mare è rappresentato dall'uscita in Atlantico della corazzata "Bismark", orgoglio della marina germanica, per una caccia in grande stile al traffico mercantile nemico. Impostata nei cantieri Blohm e Voss di Amburgo nel 1936 e varata il 14 febbraio 1939, la "Bismarck" era la più grande e la più potente nave da guerra della marina germanica. Lunga 251 metri e larga 36, aveva lo scafo assai ben protetto. La cintura corazzata aveva uno spessore massimo di 320 millimetri, mentre le torri dei pezzi da 380 millimetri erano protette con piastre dello spessore massimo di 356 millimetri e la protezione orizzontale consisteva in un ponte corazzato dello spessore di 203 millimetri. Aveva, inoltre, un elevato numero di compartimenti e paratie a tenuta stagna che davano un alto grado di sicurezza anche per le parti immerse. Le paratie erano realizzate in acciaio speciale di elevate caratteristiche di durezza ed elasticità, capaci di sopportare notevoli deformazioni senza spezzarsi. Ufficialmente, il suo dislocamento, nel rispetto del trattato di Washington, dopo che la Germania per bocca di Hitler aveva denunciato nel 1935 quello di Versailles, era di 35.000 tonnellate. In realtà la "Bismarck" dislocava ben 41. 700 tonnellate che salivano ad oltre 50.000 per una crociera di guerra a pieno carico. Dopo i lavori di allestimento che durarono oltre diciotto mesi, il 24 agosto 1940 la grande corazzata tedesca, con una cerimonia ufficiale, fu consegnata alla "Kriegsmarine". La "Bismarck", quarta nave da guerra cui i tedeschi davano il nome del loro "Cancelliere di ferro", una nave bellissima, rappresentava quanto di meglio l'ingegno germanico aveva potuto produrre fino ad allora nel campo delle costruzioni navali. Era armata con otto cannoni da 380 millimetri, in quattro torri binate, in grado di mandare alla distanza di venti miglia una bordata di oltre sette tonnellate di proiettili ad alto esplosivo. Dodici pezzi da 150 millimetri, sedici da 105 antiaerei, sedici mitragliere antiaeree da 37 millimetri e sei tubi lanciasiluri ne completavano l'armamento. L'equipaggio era costituito normalmente da duemila uomini fra graduati e marinai. La sua velocità, eccezionale per un'unità così potentemente armata, raggiungeva i 31 nodi. Si trattava, quindi, di una nave modernissima. Per la sua prima uscita di guerra in Atlantico le fu affiancato come compagno, per l'operazione "Rhein", l'incrociatore pesante "Prinz Eugen" di diecimila tonnellate, anch'esso armato nel 1940. La "Bismarck" salpò da Gdynia il 19 maggio 1941 al comando del Capitano Lindemann, battendo l'insegna dell' Ammiraglio Giinter Liitjens, che si era imbarcato su di essa per dirigere la crociera delle due navi corsare. Dopo una navigazione senza incidenti, il 21 maggio la '''Bismarck" ed il "Prinz Eugen" entrarono a Korsfjord a sud di Bergen in Norvegia, per rifornirsi di combustibile. Quì vennero scoperte da un ricognitore inglese che si affrettò a tornare alla base ed a consegnare le fotografie scattate al comandante in capo della "Home Fleet", Ammiraglio Sir John Tovey, che doveva diventare l'implacabile avversario di Liitjens nei giorni seguenti. L'Ammiraglio inglese intuì immediatamente che i tedeschi stavano per mandare le due navi in Atlantico e pensò con sgomento che in quel momento la Gran Bretagna aveva già in navigazione nello stesso oceano, ben undici convogli fra i quali il "WS-8-B" che trasportava ventimila soldati inglesi per il fronte africano. Si affrettò, pertanto, ad inviare da Scapa Flow gli incrociatori "Suffolk" e "Norfolk" la corazzata "Prince of Wales" e l'incrociatore da battaglia "Hood" a vigilare lo stretto di Danimarca unitamente ad uno stuolo di cacciatorpediniere. Per impedire, poi, la possibile fuga delle navi germaniche fra le Faer oer e l'Irlanda, vi mandò gli incrociatori leggeri "Arethusa", "Birmingham" e "Manchester". Dispose, inoltre, che la portaerei "Victorious" e la corazzata "Repulse" si dirigessero anch' esse verso il nemico; a Scapa Flow, base vitale della "Home Fleet", fece mettere sotto pressione la sua nave ammiraglia: la corazzata "King George V" e quattro incrociatori; ordinò, infine, al vice Ammiraglio Somerville di salpare da Gibilterra con l'incrociatore da battaglia "Renown", la portaerei "Ark Royal" e l'incrociatore leggero "Sheffield". Tutta la "Home Fleet" era quindi in allarme; la regina dei mari aveva steso i suoi tentacoli e le due navi tedesche dovevano necessariamente cadere nella trappola che, con tanta rapidità e dovizia di mezzi, era stata loro tesa. Nel frattempo, nella notte del 21 maggio, la "Bismarck" ed il "Prinz Eugen" lasciarono l'accogliente fiordo norvegese mettendo la prua all'ovest. Sul mare si stendeva una coltre nebbiosa che le nascondeva all' osservazione aerea nemica. Per tutto il 22 maggio gli inglesi cercarono disperatamente di individuare le due unità germaniche. Nella serata del 23, mentre la nebbia persisteva, l'Ammiraglio Liitjens portava le sue due navi nello stretto di Danimarca. Questo passaggio obbligato fra Irlanda e Groenlandia misura nel punto più stretto 180 miglia, ma per buona parte era ostruito dai ghiacci e dai campi minati inglesi. Liitjens, in previsione di cattivi incontri ordinò il posto di combattimento. Alle 19,22 l'incrociatore inglese "Suffolk" localizzò le due navi tedesche e ne segnalò la posizione continuando poi a seguirle. Poco più tardi anche l'incrociatore "Norfolk" stabilì il contatto radar. Gli operatori radar della "Bismarck", a loro volta, rilevarono i due incrociatori inglesi che prudentemente si tenevano ai limiti di portata dei localizzatori. Per togliere di mezzo gli inseguitori che continuavano a tallonarlo ed a segnalarne la posizione, il comandante tedesco, dopo aver tentato più volte di seminarli, diresse su di loro ed alle 22,28, avvistato il "Suffolk" che appariva e spariva fra i banchi di nebbia, ordinò di aprire il fuoco. Sorpreso dalla manovra, !'incrociatore inglese accostò e in breve scomparve nella notte proteggendosi con cortine fumogene. La corazzata tedesca riprese così la sua rotta. All'alba del 24 maggio la visibilità era buona, la giornata freddissima: alle 5,35 l' Hood e la Prince of Wales che si erano avvalse delle informazioni fornite dal Suffolk avvistarono la "Bismarck" e il "Prinz Eugen" di prora a dritta. Due minuti dopo le quattro navi aprirono il fuoco: alle 6 l'Hood incassò una bordata della "Bismarck" che esplose al centro della nave facendo saltare in aria le riservette dei pezzi antiaerei. Tre minuti dopo, da dodici miglia di distanza, partì la terza bordata della "Bismarck"; essa si abbatté sull’ Hood squarciandolo e penetrando in uno dei depositi munizioni. Un bagliore accecante salì verso il cielo: l'incrociatore da battaglia "Hood", la nave più pesante del mondo, che dislocava 46.300 tonnellate, orgoglio della marina britannica, non esisteva più. Varato nel 1918 e successivamente rimodernato, aveva però una protezione troppo debole in rapporto al potere distruttivo dei grossi calibri; la sua corazza orizzontale infatti era di soli 95 millimetri. Con l' "Hood" sparirono fra i flutti l'Ammiraglio Holland, 94 ufficiali e 1324 marinai; successivamente dal combustibile che si era steso sul mare, vennero estratti i tre unici superstiti. A bordo delle navi tedesche che non avevano ancora incassato un colpo, la vittoria fu salutata con urla di gioia che si ripercossero come un boato in tutti i locali. I cannoni della "Bismarck" e del "Prinz Eugen" si erano nel frattempo volti verso la corazzata "Prince of Wales" che era ormai a sole nove miglia; in breve l'unità britannica fu squassata da quattro proiettili da 380 e da tre da 203 millimetri e ridotta a poco più di un pontone, ma con una delle sue ultime salve, prima di ritirarsi lasciandosi dietro cortine fumogene che a stento nascondevano gli incendi di bordo, riuscì a danneggiare la "Bismarck". Un proiettile da 356 millimetri colpì la prua e forò una cassa prodiera di combustibile, un altro distrusse il locale macchine numero due. Avarie comunque riparabili che non compromettevano in alcun modo la combattività della nave germanica. Il "Prinz Eugen" era uscito incolume dallo scontro ed i tedeschi che avevano avuto solo cinque feriti e nessun caduto, poterono assaporare per un attimo l'ebrezza della vittoria. Ma la "Bismarck" lasciava dietro di sé una lunga scia di nafta e il colpo incassato a prua costrinse l'Ammiraglio Liitjens a rivedere i suoi piani ed a comunicare a Berlino che avrebbe fatto rotta su St. Nazaire per mettersi sotto la protezione delle forze aeree tedesche e riparare i danni. Alle 18 dello stesso giorno ordinò al "Prinz Eugen" di staccarsi e di proseguire da solo in Atlantico per la guerra di corsa. Di lì a poco l'incrociatore accostò ed in breve sparì fra i piovaschi per compiere la sua missione, mentre la "Bismarck" andava incontro al suo destino. La "Home Fleet" al completo prese il mare per vendicare l'affondamento dell’ Hood e, mentre gli incrociatori 'Norfolk" e "Suffolk" ne seguivano la rotta mantenendo il contatto radar, il cerchio si stringeva inesorabilmente attorno alla nave tedesca. Il maltempo impedì il successo di due attacchi di otto aerosiluranti lanciati dalla nuova portaerei "Victorious" distante ancora 120 miglia. A mezzanotte la "Bismarck", attaccata da un solitario aerosilurante sbucato improvvisamente dalle nubi, fu colpita da un siluro che non le causò gravi avarie. La sua navigazione verso la costa francese proseguì dirigendo su Brest, di oltre 100 miglia più vicino di St. Nazaire. Nella notte, alle 3,06, a causa dei continui cambiamenti di rotta che gli inseguitori erano costretti a fare per sfuggire a possibili attacchi dei sommergibili tedeschi chiamati in aiuto dall' Ammiraglio Liitjens, la "Bismarck" scomparve dagli schermi radar inglesi. Per lunghe ore le navi britanniche batterono il mare senza riuscire a ristabilire il contatto radar, poi l'Ammiraglio tedesco, che non si era reso conto di aver seminato il nemico, commise una fatale leggerezza: fece trasmettere a Berlino per radio un lungo rapporto sul vittorioso combattimento sostenuto, sulle condizioni di efficienza della nave e sull' allontanamento del "Prinz Eugen". La trasmissione venne intercettata, però, anche dall' Ammiraglio britannico, che in breve tempo riuscì a localizzare la posizione della corazzata tedesca. In effetti il punto che fornì l'Ammiraglio era errato e soltanto nel tardo pomeriggio, quando le sue navi correvano da ore dietro a un fantasma, a seguito del fortuito avvistamento della "Bismarck" da parte di un idrovolante "Catalina" del Comando Costiero della RAF, dette la posizione esatta. Quando gli inseguitori misero finalmente la prua sulla rotta giusta, la "Bismarck" aveva già un vantaggio di 150 miglia. L'Ammiraglio Tovey sapeva che, se non interveniva un fatto nuovo, la corazzata tedesca sarebbe riuscita a raggiungere Brest ponendosi in salvo; ordinò, quindi, all"'Air Royal" di effettuare degli attacchi con gli aerosiluranti nella speranza di colpirla e di rallentarne la marcia. Quando gli aerei britannici presero il volo dal ponte dell"'Ark Royal, spazzato dal vento e dalla pioggia, erano le 14,50 del 28 maggio. Gli "Swordfish" si allontanarono e dopo un'ora, avvistata una grossa unità, andarono all'attacco lanciando, per un errore che poteva avere tragiche conseguenze i loro quattordici siluri contro l'incrociatore inglese "Sheffield" che manovrando riuscì miracolosamente ad evitare di essere colpito. Al termine dell'azione i piloti si resero conto di aver silurato una loro nave e tornarono mortificati alla portaerei per fare rifornimento. Nello stesso momento il sommergibile tedesco "U-556" inquadrava perfettamente nel suo periscopio l’ Ark Royal ed il Renown, ma il Comandante Wohlfahrt non poté affondare le ignare navi nemiche perché aveva esaurito i siluri. Intanto gli "Swordfish" , protagoni¬ti della disavventura precedente, terminato il rifornimento e riarmati di siluri, decollarono nuovamente, al comando del Capitano di corvetta Tim Coode. Alle 19,10 sorvolarono lo "Sheffield'" ed alle 20,53 il primo di essi iniziò l'attacco alla "Bismarck". Furono lanciati 13 siluri, dei 15 a disposizione, senza riuscire a colpire la corazzata tedesca che, nonostante la sua mole, con rapide accostate e sparando con tutte le sue armi antiaeree, riuscì ad eludere l'offesa degli aerosiluranti britannici. Nel cielo infuocato dagli scoppi dei proiettili antiaerei apparve poi una seconda ondata di undici "Swordfish". Era l'ultimo attacco della giornata, prima che il sopraggiungere dell'oscurità costringesse l’Ark Royal a sospendere l'azione fino all'alba del giorno seguente, consentendo così alla "Bismarck" di distanziare vieppiù la muta dei suoi inseguitori. I piloti inglesi, consapevoli che quella era l'ultima occasione che avevano a disposizione per fermare o almeno per rallentare la grande corazzata tedesca, attaccarono con grande determinazione e, malgrado l'impressionante reazione antiaerea, riuscirono a mettere a segno due siluri. Uno esplose al centro della nave senza causare alcun danno, l'altro invece, per puro caso o se vogliamo per uno scherzo del destino, durante un'accostata, colpì l'unità a poppa nell'unico punto vulnerabile, il timone. L'esplosione sfondò i locali dov' era situato l'apparato del timone allagandoli, danneggiando gli impianti e bloccando i timoni alla banda. Il siluro aveva colpito in un modo e in una posizione particolari, un'eventualità che, a giudizio dei tecnici navali tedeschi, aveva una probabilità su centomila di verificarsi. I danni erano tali da rendere comunque impossibile ogni riparazione in mare e il comandante tedesco, dopo un primo sommario esame se ne rese immediatamente conto. Da quel momento, la potente unità germanica che non riusciva più a manovrare, aveva perso la sua corsa verso Brest e verso la salvezza. Dopo disperati, ma inutili tentativi di sbloccare i timoni, l'Ammiraglio Liitjens inviò a Berlino il seguente messaggio: "- Non è più possibile governare la nave. Combatteremo fino all'ultimo proietto. Lunga vita al Fuhrer.-" Intanto, dopo aver girato in tondo due volte, la "Bismarck" serpeggiando, si muoveva lentamente sfruttando alternativamente le eliche per poter dirigere in qualche modo il suo moto, ma il suo destino era ormai segnato. Il Capitano Lindemann e l'Ammiraglio Liitjens erano pienamente consci di aver perso la partita, ma non potevano più far nulla per sovvertire il corso degli avvenimenti: a quel punto non restava che attendere l'arrivo degli inseguitori per combattere l'ultima battaglia. Alle 22,30 una fiottiglia di cacciatorpediniere inglesi, al comando del Capitano Vian, attaccò la corazzata germanica e riuscì a colpirla con un siluro che però non perforò la blindatura della prua. L'Ammiraglio Lutjens, dopo che le vedette, alle 8,43 del 27 maggio avevano avvistato le corazzate "King George" e "Rodney", parlò all'equipaggio; la radio trasmise in tutti i locali le sue ultime parole: "- Parla l'ammiraglio, siamo circondati da unità nemiche. Se il destino vorrà che moriamo per la patria, cadremo da bravi marinai. La nostra bandiera sventolerà fiera fino alla fine. Aufwiedersehen!-" Alle 8,47, le navi aprirono il fuoco da ambo le parti, ma per la "Bismarck" non c'era alcuna possibilità di scampo: la nave senza timone non poteva manovrare e gli avversari, con il sopraggiungere di tutti gli inseguitori, aumentavano sempre. L'impari lotta si protrasse per un'ora e trentotto minuti; poi il Capitano Lindemann ordinò di abbandonare la nave, ridotta ad un pontone fiammeggiante. Ma sembrava che la " Bismarck", pur così straziata, non volesse affondare; si avvicinò, allora, l'incrociatore "Dorsetshire" e, incurante delle centinaia di marinai tedeschi che nuotavano attorno alla grossa nave, le lanciò contro, in rapida successione, tre siluri che con la loro esplosione straziarono i naufraghi. Alle 10,36, la "Bismarck" con la bandiera al vento si inabissava lentamente trascinando con sé, nel risucchio spumeggiante del gorgo che si era formato, centinaia di marinai, oltre al Capitano Lindemann e all' Ammiraglio Lutjens, ai quali l'antica tradizione del mare imponeva di condividere la sorte della propria nave. Successivamente, le navi inglesi trassero in salvo 110 superstiti ed alcuni altri furono salvati dal sommergibile germanico "U-47", ma molti altri erano nel frattempo annegati, perché i britannici, per timore degli U-Boote, avevano interrotto quasi subito le operazioni di salvataggio. Circa duemila marinai tedeschi, fra i quali quattrocento allievi della scuola navale che non avevano ancora superato il diciannovesimo anno di età, erano scesi per sempre in fondo al mare. La "Home Fleet" , alla quale il fato, dopo l'affondamento dell' Hood, era stato più volte benigno, era riuscita a vendicare, nello spazio di poche ore, una delle più umilianti sconfitte subite sul mare dall'Inghilterra in tutta la sua storia. Ancora una volta l'antico adagio britannico "non esiste nulla di più terribile al mondo dei cannoni inglesi manovrati dai marinai inglesi", aveva avuto la sua tragica conferma: la "Bismarck", che aveva spiegato al vento con orgogliosa fierezza la sua bandiera di combattimento sfidando la regina dei mari, giaceva per sempre negli abissi. Nel valutare questo scontro, ormai assurto a fatto storico di rilievo, non va dimenticato il ruolo decisivo che ebbe l'aeroplano in questa come nella maggior parte delle battaglie navali della seconda guerra mondiale. È infatti evidente che, senza l'avvistamento effettuato dal "Catalina", la "Home Fleet" avrebbe continuato a navigare a vuoto mentre la "Bismarck" sarebbe riuscita ad allontanarsi del tutto indisturbata e in via definitiva. E successivamente, anche dopo essere stata avvistata, avrebbe ancora potuto salvarsi, se il siluro dell'ultimo "Swordfish" prima del sopraggiungere del buio, non le avesse così fortunosamente bloccato il timone. Malgrado quindi la grande potenza e la giusta fama della "Royal Navy", senza i due interventi aerei sopra citati la flotta inglese non sarebbe riuscita, pur con tutte le sue navi e con tutti i suoi cannoni, a raggiungere la "Bismarck" ed a vendicare l'affondamento dello "Hood" ed il grave danneggiamento della "Prince of Wales" Giorgio Evangelisti Aeronautica Febbraio 1996
-
Croci rosse, fiaschi e cannonate Il 25 Novembre 1941, alle ultime luci serali e senza gregari, silurai una navicella ferma fuori del porto di Tobruch. Era illuminata in modo che io ritenni necessario ad agevolare le sue operazioni di scarico. Non la colpii, perché forse il siluro si guastò o forse le passò sotto, tanto era piccina. Fu una fortuna perché, dopo il lancio del siluro, il mio marconista Aldo Becatti si accorse che era una nave ospedale, perché era illuminata e perché le luci stesse gli consentirono di scorgere una croce rossa dipinta su una sua fiancata. Chiesi scusa per radio, in italiano e su una frequenza internazionale, spiegando che non mi ero accorto che era una nave ospedale. L'episodio è riferito dal Generale Giuseppe Santoro, già Sotto capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, nel suo libro sulla storia dell'Aeronautica in guerra. Quella prima croce rossa, apparsa tra le fortuite circostanze del mio racconto, e il fallito siluramento della nave ospedale, mi portarono veramente fortuna, come vedremo. Ma l'incontro con un'altra nave ospedale, pochi giorni dopo, fu più strettamente connesso col finale del mio racconto. Un'altra circostanza casuale, più divertente, accadde negli ultimi giorni di novembre, quando un mattino incontrai un Ufficiale della "Luftwaffe" che, insieme ad un interprete, gironzolava incuriosito intorno a un mio aeroplano dotato di siluro. Mi presentai ed invitai i due a colazione. Si trattava del Tenente Colonnello Christ, che in quei giorni sostituiva temporaneamente il Comandante della Luftwaffe in Libia, come mi riferì l'interprete Dottor Fuchs, che prima e dopo la guerra diresse a Roma un importante istituto italo-germanico di cultura. Passando accanto alla baracca della mensa Christ adocchiò un mucchio di fiaschi vuoti e me ne chiese un certo numero, per mettervi dentro del caffè crudo che voleva spedire alla moglie, ed evitare, così, che il caffè ammuffisse. Aderii di buon grado alla sua richiesta e gli regalai anche una cassa di fiaschi di buon Chianti. Dopo il brindisi Christ mi domandò come poteva contraccambiare i miei doni ed io gli chiesi il cifrario e la frequenza radio dei suoi ricognitori, in modo da poterne utilizzare tempestivamente i segnali di scoperta di navi. Christ aderì alla mia richiesta e il giorno dopo mi mandò un Tenente con quanto desideravo. Insomma, col Chianti avevo corrotto, o se volete convinto, un rigido e potente Ufficiale Superiore germanico, che in quei giorni sostituiva nientemeno che il Generale Kesserling . Avvertii subito il Generale Raffaelli della mia iniziativa e misi il bravo marconista Becatti in ascolto sulla frequenza dei ricognitori tedeschi. Così, il 1° dicembre, verso le undici del mattino, sapemmo dai ricognitori germanici che, poco prima, quattro navi da guerra britanniche erano passate a sole dieci miglia a nord di Derna, con rotta est e a gran velocità. Bisognava dunque raggiungerle, prima che fossero protette dai caccia. Solitamente frettoloso e nervoso, quella volta lo divenni come non mai, e concitatamente telefonai al Colonnello Capo di Stato Maggiore del Comando di Settore, per avere subito l'autorizzazione al decollo con due gregari. Lui mi rispose, con molta flemma, che il Generale Raffaelli era fuori sede e che era difficile trovarlo telefonicamente, per chiedergli il permesso da me richiesto. Allora feci finta di non capirlo a causa di un immaginario guasto telefonico, e decollai in fretta e furia con gli indimenticabili gregari Aligi Strani e Pinotto Coci. Assunta rotta est, sul traverso di Tobruch avvistammo un grosso piroscafo, che con rotta sud andava verso il porto, in pieno giorno, ora insolita per le navi dirette alla piazzaforte assediata. Era un obiettivo facile ed importante, per ostacolare i rifornimenti a Tobruch. Seguito dai gregari lo puntai, ma poi... vidi una croce rossa dipinta sulla sua fiancata. "Ancora una croce rossa, questa è una persecuzione", pensai. Desistetti dall'attacco, accostai un poco a sinistra, passammo tutti e tre dietro la poppa della nave e proseguimmo verso est. Poco dopo avvistammo le quattro unità segnalateci dai tedeschi: erano due incrociatori con due cacciatorpediniere ai loro lati, molto accostati tra loro e in linea di fronte, ad alta velocità, come risultava dalle loro scie spumeggianti. A tutto motore ci avvicinammo alle navi salendo un po' in quota ed entrando e uscendo da un banco di nuvolette esteso alla loro destra. Arrivato alloro traverso virai a sinistra e picchiai a capofitto per scendere rapidamente alla quota di cento metri, necessaria per il lancio del siluro. Lo mollai a breve distanza dalla prima unità a destra della formazione, mentre le navi concentravano i loro tiri contro il mio velivolo, che era in testa alla pattuglia. Subito dopo il lancio effettuai un'elegante virata a destra, in cabrata, ma il velivolo fu subito colpito all'estremità dell'ala destra, poi al carrello che venne fuori dal suo alloggiamento gravemente lesionato (come accertarono i miei specialisti di bordo), infine furono colpiti i serbatoi della benzina, che miracolosamente non si incendiò. Tuttavia ne perdevo un grosso flusso, nebulizzato in una scia fumosa. Fino all'atterraggio temetti l'esaurimento del carburante. Dopo il mio lancio la formazione navale si allargò e si scompigliò, tanto che Strani riuscì a silurare il mio stesso obiettivo sul lato destro e Coci su quello sinistro. Poi ambedue mitragliarono le altre navi, prima di sorvolarle. In questi casi alcuni serventi delle mitragliere delle navi scappavano in cerca di riparo e la massa di fuoco diminuiva sensibilmente. Pertanto anche io, dopo il lancio del siluro, avrei dovuto fare altrettanto, anziché esibirmi in una piroetta, sotto il fuoco nemico. Dopo essermi tanto celebrato, un po' di autocritica non guasta. Ma quell'esperienza mi servì in altre occasioni. Nel parapiglia successivo al mio lancio un solo siluro colpì, a poppa, il cacciatorpediniere "Jackal". Dio solo sa chi di noi tre lo abbia colpito, perché credo che in quella confusione neanche gli inglesi lo abbiano realizzato. Mentre ci allontanavamo a tutto motore dalle navi, inseguiti dalle loro cannonate, in coda ai velivoli i nostri equipaggi videro che la nave colpita aveva la prua fuori dall'acqua e così credemmo che stesse affondando. Ma poi, dopo la guerra, si seppe che i suoi locali poppieri allagati furono isolati prontamente e che essa potette tornare ad Alessandria. Col carrello lesionato ero sicuro di fare un atterraggio pericoloso. A causa del blocco degli indicatori del livello del carburante non sapevo se avevo la benzina bastante a raggiungere l'aeroporto e una quota sufficiente al lancio in paracadute su di esso. Perciò rinunciai a salire in quota e, come Dio volle, raggiunsi l'aeroporto a bassa quota e a motori ridotti, per economizzare benzina. Decisi di atterrare lungo il limite nord del campo, per evitare che la carcassa del mio velivolo ostacolasse poi l'atterraggio di altri aeroplani. Come avevo previsto, appena toccato terra cedette il carrello, già sconquassato dai colpi dei fieri britanni, e il velivolo strusciò la terra con la fusoliera, sobbalzando. Temevo che una scintilla potesse scoccare per lo sfregamento della fusoliera stessa sul terreno sassoso. Ad ogni buon conto, per scendere in fretta dal velivolo appena fummo fermi, col carissimo secondo pilota Sergente Gioacchino Arcarisi sganciammo il tettuccio sovrastante i posti di pilotaggio, saltammo sulla ala e poi in terra, dove affondai le gambe fino al polpaccio in un laghetto di benzina, che in caso di scintilla avrebbe prodotto un micidiale falò. Intanto gli altri quattro dell'equipaggio erano già usciti ruzzolando dalla porta della fusoliera, ancor prima che il velivolo si fermasse. Per la soddisfazione di essere tornati tutti incolumi, di avere finalmente operato di giorno e di aver preso delle iniziative tanto pericolose quanto fortunate, ringraziai Dio, e tuttora lo ringrazio per avermi concesso di servire per tanti anni la Patria, nella buona e nella avversa sorte. Quale esempio di buona sorte ricordo la giornata del 1° dicembre 1941 come la più bella nella mia vita di combattente, al tempo ormai lontano della giovinezza. Aeronautica Ottobre 1989
-
Obiettivo LUNA Agli albori dell'astronautica le conoscenze dell' uomo sulla Luna erano estremamente ridotte. Non si sapeva quale consistenza avesse la sua superficie, se fosse coperta da una spessa coltre di polvere oppure se l'esistenza di enormi crepacci potessero mettere in pericolo uomini e mezzi. L'assalto sovietico verso la Luna iniziò nel 1959 con il Lunik l per concludersi il 9 agosto 1974 con la sonda Luna 24. L'intero programma, che comprese più di 50 sonde, consentì ai russi di acquisire informazioni importanti sul nostro satellite raggiungendo nel contempo numerosi primati: fra questi il primo oggetto costruito dall'uomo a essere inviato verso la Luna; il primo a colpirla; la prima foto della sua "faccia" nascosta, il primo atterraggio morbido; il primo satellite artificiale in orbita intorno a essa; il primo capace di raccogliere campioni del suolo e riportarli a terra; e, per concludere, i primi veicoli automatici semoventi, i Lunakod, i quali teleguidati da terra esplorarono la superficie lunare coprendo una distanza di oltre 40 km. Il programma Sovietico Il maggiore artefice dei successi spaziali sovietici fu Sergej Korolev. A lui il governo affidò, negli anni 50, tre compiti di estrema importanza: verificare le reali possibilità dell'uomo ad operare nello spazio; studiare la Luna con l' ausilio di satelliti automatici; progettare un nuovo supervettore per l’ esplorazione del sistema solare. Grazie al genio creativo di Korolev e del suo staff, l'URSS ebbe presto l'R7 (codice NATO SL-1 o A-1), un vettore le cui potenzialità furono ampiamente dimostrate con il lancio dello Sputnik 1, primo satellite della storia, e del primo satellite verso la Luna, il Lunik. Con la crescita del programma spaziale aumentò l'esigenza per i sovietici di maggiori potenze e l'OKB-1, l'ufficio tecnico diretto da Korolev, riuscì a incrementare le capacità iniziali del vettore ottenendo nuove versioni migliorate e denominate di volta in volta col nome delle astronavi da lanciare quali le Vostok, le Voshkod e le Soyuz, ma era evidente che una missione lunare con uomini a bordo avrebbe richiesto potenze di gran lunga maggiori. Per questo Korolev pensò a un vettore completamente nuovo, capace di portare in orbita carichi di 40-50 t denominato N1 (codice NATO G-le). Egli ne prevedeva il primo lancio entro il 1965 e nelle sue intenzioni doveva costituire un primo passo verso una seconda versione denominata N2, con capacità di carico pari a 60-80 t. Pur senza l'appoggio ufficiale del governo, il progettista iniziò uno studio di fattibilità del vettore. Per i motori si affidò inizialmente a Valentin P. Glushko che aveva già al suo attivo i motori dell'R7 e stava progettando anche quelli per il Proton, che come propellenti avrebbero usato tetrossido di azoto e dimetilidrazina. Glushko insistette energicamente nel voler usare per l'N1 gli stessi propellenti, in netto contrasto con Korolev, che era assolutamente contrario all'uso di propellenti ipergolici per via della loro estrema tossicità e aveva ragione di preoccuparsi se si considerano le enormi quantità di propellente richiesto per lanciare l'N1. Il conflitto fra i due progettisti obbligò Korolev ad affidare la progettazione dei motori a un altro progettista, Nikolaj D. Kuznetsov. Questa scelta però costrinse Korolev a rinunciare definitivamente alle speranze di poter usare ossigeno e idrogeno liquidi, in quanto Kuznetsov non aveva un' esperienza rilevante nel campo dei motori a razzo criogenici. Di comune accordo i due scelsero come propellenti l'ossigeno e il cherosene, stessa scelta che fecero gli americani per il primo stadio del Saturno 5, che pur essendo meno energetici avevano però il pregio di richiedere motori meno complessi. Sempre allo scopo di semplificare il progetto e ridurre i tempi di costruzione, si decise di impiegare più motori di spinta modesta invece che pochi ma potenti, una soluzione questa opposta a quella presa dagli americani. Finalmente nel gennaio del 1962 cominciarono ad apparire sui tavoli dei progettisti i primi disegni dell’ N1, un gigantesco vettore dal profilo fortemente conico a causa della forma sferica dei serbatoi carburante e del peso oltre 3.200 t. Il primo stadio avrebbe impiegato ben 24 NK-33, i nuovi motori progettati da Kuznetsov. Con un carico utile di 75 t se ne prevedeva il primo lancio entro il 1965. Di pari passo Korolev partendo dalla Soyuz, la nuova astronave che stava sviluppando in sostituzione della Vostok e della Voshkod, mise a punto il modulo orbitale lunare Zond. Forte del vantaggio accumulato in campo spaziale, l'Unione Sovietica non prese in considerazione ufficialmente la conquista della Luna fino a quando il presidente J.F. Kennedy dichiarò al mondo l'intenzione degli Stati Uniti di conquistare il nostro satellite prima della fine degli anni 60. Questa dichiarazione indusse il premier sovietico Khrushchev a prendere in considerazione una missione lunare affidando a Vladimir N. Chelomei, che era a capo dell' ufficio progetti dell' OKB-52, il compito di costruire nel più breve tempo possibile un nuovo vettore capace di portare un veicolo con un cosmonauta a bordo in una missione di circumnavigazione lunare. Ciò pose le basi per la nascita del Proton (UK 500 K), ancora oggi il più celebre dei vettori sovietici, ma di fatto portò via tempo e investimenti all'N1 rivelandosi fatale per il prosieguo dello sviluppo, che in pratica era già in fase avanzata di progettazione. Una volta costruito, il vettore avrebbe permesso non solo di circumnavigare la Luna ma addirittura di sbarcare su di essa. In attesa di momenti migliori Korolev continuò a migliorare le prestazioni dell'N1 al quale aggiunse altri sei motori portando il carico utile a oltre 92 t. Mentre il programma Proton procedeva, nell'agosto del 1965 Korolev presentò alla commissione governativa chiamata a decidere sullo spazio un nuovo progetto chiamato ufficialmente "Un lavoro coinvolgente lo studio della Luna e dello spazio esterno" che prevedeva l'uso dell'N1 e lo sbarco di un russo sul nostro satellite per il 1968. La commissione, incalzata dai successi degli americani nello spazio, approvò il progetto di Korolev rivedendo l'intero programma di circumnavigazione lunare col Proton e dando al progettista stesso pieni poteri su entrambi i programmi. Purtroppo Korolev non fece in tempo a portare a termine il proprio lavoro. Pochi mesi dopo, nel gennaio del 1966, morì improvvisamente privando l'Unione Sovietica e il mondo intero di uno dei più grandi progettisti di missili mai esistiti, le cui capacità avevano permesso all'URSS di dominare nello spazio. A capo del progetto Luna fu messo Vasilij P. Mishin, il suo più stretto collaboratore, ma la mancanza di un genio creativo come Korolev si fece sentire e tutto il programma spaziale subì un forte rallentamento. Quando nel novembre del 1966, il governo approvò i piani per la costruzione del supervettore N1 e dell'astronave lunare L-3, comprendente il razzo di trasferimento, il modulo orbitale e il modulo lunare, l'Unione Sovietica si trovò ad avere due programmi lunari distinti, uno di circumnavigazione, da effettuarsi con il vettore Proton e uno di sbarco in predicato col missile N1. Nel frattempo un primo gruppo di venti cosmonauti, del quale facevano parte Aleksej Leonov e Valerij Bykovsky, iniziò ad allenarsi per una missione di circumnavigazione e, sempre lo stesso anno, iniziarono i primi test orbitali delle cosmonavi Zond e dei moduli lunari. Nonostante le difficoltà i sovietici erano ancora ottimisti sulle loro possibilità di raggiungere la Luna prima degli americani almeno con un volo orbitale, con la previsione di sbarcare sul nostro satellite entro la fine degli anni 60. Per questo motivo moltiplicarono gli sforzi per completare al più presto le necessarie infrastrutture presso la base spaziale di Baikonur, la grandezza delle quali non poteva certamente passare inosservata ai servizi segreti statunitensi. Il Gigante di Webb L'Occidente venne per la prima volta a conoscenza del supervettore russo nei primi mesi del 1967 per voce dell' allora direttore della NASA James Webb, il quale durante una riunione della commissione della Casa Bianca per lo spazio dichiarò che l'Unione Sovietica era in procinto di costruire un gigantesco vettore con una spinta di 5 milioni di kg. La pressione emotiva di questa notizia contribuì a cancellare ogni residua perplessità nel governo americano che concesse alla NASA tutti i fondi richiesti per il programma lunare. Un anno dopo la missione americana Apollo 8, con a bordo gli astronauti Bormann, Lovell e Anders, raggiunse il nostro satellite compiendo per la prima volta 10 orbite intorno a esso. Nonostante la sconfitta i russi non si persero d'animo e, tralasciando il programma di circumnavigazione lunare, si orientarono completamente nella realizzazione e nel collaudo del nuovo vettore, programmandone il primo lancio agli inizi del 1969. Si mirava così solo allo sbarco diretto sul nostro satellite, un obiettivo teoricamente ancora alla loro portata. Pressati dal governo ad anticipare i tempi, i responsabili del programma furono costretti a ridurre al minimo tutte le procedure di controllo e collaudo del vettore, per cui passarono direttamente al montaggio dei propulsori nei vari stadi senza prima effettuare delle prove vincolate a terra per verificare se fossero in grado di funzionare insieme senza problemi. Una decisione avventata che non teneva conto delle preoccupazioni esternate dai tecnici incaricati del progetto e che si basava sul fatto che se i motori erano già stati collaudati separatamente in fabbrica questi avrebbero funzionato bene anche insieme. Ne conseguì che i sovietici costruÌrono un vettore le cui vere capacità erano ipotetiche e sulla cui messa a punto ci si doveva affidare ai soli lanci di collaudo cosa che, in caso di malfunzionamenti, avrebbe potuto mettere a repentaglio, oltre all'integrità del vettore, le vite dei tecnici adibiti al lancio. Mentre la costruzione del vettore procedeva velocemente, ai sovietici restava ancora da mettere a punto la questione del trasferimento dell' equipaggio dal modulo di comando Zond al modulo lunare (LK), problema che gli americani avevano risolto brillantemente con l'adozione di un tunnel di collegamento interno che si apriva quando il modulo di comando Apollo era unito al modulo lunare. Per lo stesso scopo i sovietici decisero invece di adottare il trasferimento da un modulo all'altro grazie ad una passeggiata spaziale. Il 14 gennaio del 1969 essi lanciarono nello spazio la Soyuz 4 con a bordo un solo cosmonauta (Vladimir Shatalov) seguita pochi giorni dopo dalla Soyuz 5, con a bordo tre membri d'equipaggio (Boris Volynov, Aleksej Yeliseyev e Yevgenj Khrunov). Il 16 gennaio le due cosmonavi effettuarono un perfetto aggancio in orbita e i cosmonauti si prepararono a compiere il pericoloso esperimento. A bordo della Soyuz 5 Yeliseyev e Khrunov indossarono le loro tute spaziali e una volta depressurizzata la cabina ne uscirono, uno alla volta, per raggiungere la Soyuz 4 dove era ad attenderli Shatalov. In questo modo essi simularono quella che doveva essere la modalità di trasferimento dalla Zond all'LK. Dopo 37 minuti di alta tensione , era la prima volta che si tentava nello spazio un esperimento del genere , i due si sistemarono definitivamente all'interno della Soyuz 4, ripressurizzarono il veicolo e rientrarono con esso a terra il giorno dopo. L'esperimento era riuscito felicemente e non restava che metterlo in pratica in una missione lunare. Giusto un mese più tardi i frutti dei lunghi lavori effettuati presso la base di lancio di Baikonur cominciarono a vedersi: dalla nuova area di lancio, pronta e già collegata da una quadrupla linea ferrata, all'immenso capannone dove il vettore, alto 103 metri e pesante oltre 2.700 t, veniva montato orizzontalmente su di un grande carrello ferroviario munito di enormi attuatori idraulici che avrebbero poi avuto il compito, una volta trasportato il vettore nell'area di lancio, di porlo verticalmente, con una tecnica in uso ancora oggi. Il Vettore Lunare Nato come risposta al Saturno 5, in realtà il vettore sovietico poteva essere comparato a quello americano solo per l'altezza in quanto la sua forma era molto più conica e usava quattro stadi rispetto ai tre del Saturno. Il complesso era composto da due sezioni che si distinguevano nettamente fra di loro: una alta 60 m e fortemente conica era composta dall' unione di tre stadi e costituiva il vettore vero e proprio (N1), l'altra, alta 43 m e cilindrica, costituiva il sistema L3 destinato a raggiungere la Luna e composto a sua volta da due stadi translunari, dal modulo orbitale e dal modulo lunare, il tutto protetto per il lancio da un' ogiva conica del diametro massimo di 6 m. I sistemi orbitali e di allunaggio poi erano completamente diversi con caratteristiche tali da permettere l'invio verso la Luna di due cosmonauti, uno solo dei quali sarebbe sceso sulla sua superficie. Il primo stadio del vettore, o blocco A, era di forma conica con un diametro alla base di 17 m e alla sommità di Il. I 28 m della struttura contenevano il serbatoio del cherosene, dal diametro di 10,5 m, e quello dell'ossigeno liquido da 12,8 m; la metà superiore del serbatoio più piccolo era sostenuta da una struttura reticolare che la univa al secondo stadio. In tutto pesava al lancio 2.000 t. Cuore del sistema erano i 30 motori NK 33 della Trud/Samara progettati da Kuznetsov, capaci di una spinta di 154 t con un impulso specifico di 331 sec; in confronto il primo stadio del Saturno 5, l'SIC costruito dalla Boeing, usava solo cinque giganteschi motori F-1 della Rocketdyne che provvedevano da soli a una spinta totale di 3.401.900 kg per 150 sec usando gli stessi propellenti dell'N1. I 24 motori erano sistemati nel perimetro esterno del vettore, mentre i restanti sei erano disposti al centro. La spinta totale calcolata per un impiego di due minuti era di 4.620.000 kg. Durante il volo il beccheggio doveva essere controllato da variazioni di potenza dei motori agli opposti; il controllo del rollio era assicurato da 4 motori indipendenti dalla spinta di 7.000 kg ciascuno. Il secondo stadio, o blocco B, era alto 20 m e sostanzialmente simile al primo. Il diametro si riduceva dagli 11 m della base ai 7,5 della cima. Anche qui c'erano due serbatoi sferici, uno per l' ossigeno e uno per il cherosene, rispettivamente di 8,5 e 7 m di diametro; similmente al primo stadio le linee di alimentazione ai motori, provenienti dal serbatoio superiore, correvano in parte all'esterno della struttura stessa. Di eguale fattura era l'anello reticolare di collegamento al terzo stadio. Il peso totale al decollo era di 540 t, i motori NK 33 modificati dallo stesso Kuznetsov al fine di sfruttare al meglio le differenti condizioni d'impiego, poi ribattezzati NK 43, avevano una spinta di 179 t ciascuno con un impulso specifico di 346 sec, per una spinta totale di 1.432.000 kg per 130 sec. Il controllo del vettore era identico a quello adottato per il primo stadio, mentre il rollio era controllato da tre motori da 6.000 kg di spinta ciascuno. Il confronto col secondo stadio S-II, costruito dalla North Americani Rockwell, del Saturno 5 è a questo punto impossibile in quanto i cinque motori J-2 della Rocketdyne che lo equipaggiavano erano criogenici funzionando con ossigeno e idrogeno liquido e garantendo una spinta totale di 453.590 kg per 390 sec. Il terzo e ultimo stadio del vettore, o blocco V, era alto 12 m con un diametro inferiore di 7,5 m e uno superiore di 6. Due serbatoi sferici di 5,9 e 4,9 m contenevano gli stessi propellenti dei primi due stadi. Solo quattro motori NK 39 della Trud/Samara erano impiegati in questo vettore che con una spinta di 41 t ciascuno per un impulso specifico di 353 sec garantivano una spinta totale di 164.000 kg per 400 sec. Il terzo stadio aveva il compito di collocare, in un' orbita di 220 km, l'intero complesso L3, il rollio era controllato da quattro razzi ognuno con una spinta di 200 kg. Nel Saturno 5 il terzo stadio S-IVB della McDonnell-Douglas Corporation aveva un solo motore J-2 da 90.720 kg e due compiti essenziali: il primo di collocare in orbita il complesso modulo lunare e di comando Apollo più servizi; il secondo di riaccendersi per spingere il trenino spaziale verso la Luna, compito questo che nel progetto sovietico era affidato a un quarto stadio facente parte del complesso L3. I gruppi propulsori erano controllati da un sistema operativo automatico (KORD) in grado di riconoscere qualsiasi malfunzionamento. In pratica, se un motore falliva il sistema lo isolava e per mantenere il missile in equilibrio spegneva il motore diametralmente opposto, aumentando contemporaneamente la durata di accensione degli altri. L'idea era buona ma la tecnica russa degli anni 60 non permetteva al sistema di avere tempi di reazione brevi, cosa che impedì di intervenire efficacemente nel corso delle avarie che si manifestarono durante i quattro tentativi di lancio dell'N1/L3 effettuati. Il Modulo Lunare LK Con un peso di 5,5 t e un' altezza di poco meno di 5 m il modulo lunare sovietico era composto da una piattaforma di atterraggio e da una cabina che poteva contenere al suo interno un cosmonauta. Un solo motore dalla spinta di 2,5 t e funzionante a tetrossido d'azoto e dimetilidrazina aveva il duplice compito di rallentare il modulo nelle fasi di avvicinamento e atterraggio nonché di consentirne il decollo, lasciando sulla superficie lunare le gambe in funzione di rampa. Pur apparendo più semplice, il complesso incorporava una importante innovazione rispetto all'LM americano, e cioè la presenza di due motori, uno dei quali di riserva che avrebbe assicurato, in caso di malfunzionamento dell' altro, il decollo dell’LK dalla Luna. La procedura prevedeva che al decollo tutti e due i motori si dovessero accendere e, una volta constatato che tutto funzionava a dovere, il sistema di bordo avrebbe provveduto a spegnere quello di riserva. I sovietici avevano studiato la possibilità di utilizzare un modulo più grande per sbarcare sulla Luna con tre astronauti, cosa che avrebbe richiesto il lancio di due vettori N1, ma la cancellazione del programma lunare impedì l'ulteriore sviluppo del progetto. I primi occidentali a poter vedere un modulo lunare sovietico furono un gruppo di ingegneri aerospaziali ame¬icani del MIT. Condotti dal prof. Jack L. Kerrebrock, alla fine degli anni 80, nel corso di una visita ai loro colleghi dell'Istituto moscovita per l'aviazione essi videro un modulo lunare LK perfettamente conservato all'interno di un magazzino dell'istituto. I Lanci Il primo lancio del complesso N1/L3 fu effettuato il 21 febbraio 1969 ma, 70 sec dopo il decollo, la rottura di un condotto dell'ossigeno liquido provocò l'esplosione del missile. Il 3 luglio 1969 un secondo vettore esplose subito dopo l'accensione dei motori distruggendo la rampa di lancio e provocando numerose vittime. L'inchiesta attribuì la sciagura a un oggetto metallico estraneo finito dentro la pompa dell'ossidante. L'esplosione fu così terrificante che i sistemi di sorveglianza americani ne registrarono l'enorme ondata di calore. I giornali diedero al fatto grande risalto. La noti¬ia del fallimento sovietico, a pochi giorni dalla missione americana di Apollo 11, fu estremamente imbarazzante per i sovietici che si vedevano così costretti ad ammettere pubblicamente la loro sconfitta nella corsa alla Luna. La ricostruzione della zona di lancio e delle sue infrastrutture richiese due anni che servirono anche a completare la seconda rampa. Nello stesso periodo il vettore fu sottoposto a numerose modifiche. Il 27 giugno 1971 il terzo tentativo: 53 secondi dopo il decollo il vettore andò improvvisamente fuori controllo costringendo i sovietici a premere il bottone dell' autodistruzione. Il quarto e ultimo lancio si ebbe il 23 novembre 1972. Il conto alla rovescia procedette in modo regolare e i 30 motori del primo stadio si accesero contemporaneamente in un fragore cupo e assordante tanto forte da far tremare la terra intorno. Lentamente, avvolto in una enorme nuvola di fumo e vapore, il vettore iniziò a salire seguendo la traiettoria stabilita. Dopo 90 secondi, sei dei trenta motori si spensero come da programma, ma la brusca interruzione produsse una sovrapressione nelle linee di alimentazione dei motori tanto forte da provocare la rottura di alcuni condotti del carburante. Il pericoloso liquido fuoriuscì incendiandosi e dopo 17 secondi il primo stadio esplose in un'immane nuvola di fiamme distruggendo, oltre a se stesso, le ultime ambizioni sovietiche di raggiungere la Luna. Quello che resta Dopo la sospensione dei lanci il programma lunare fu abbandonato ufficialmente nel 1976 e i due vettori N1 rimasti furono demoliti. Oggi a circa vent' anni di distanza, molti pezzi si trovano sparsi per la base di Baikonur trasformati in magazzini, serbatoi per l'acqua, gazebo, garage o semplicemente abbandonati alla ruggine. Le due basi di lancio sono state riconvertite per lanciare il nuovo vettore pesante Energia, così pure il gigantesco trattore per il trasporto è stato riconvertito. I motori del missile, dopo anni passati in magazzino, sono stati recentemente messi in vendita a prezzi stracciati sul mercato statunitense e potrebbero finire seriamente su qualche nuovo vettore della NASA. Rivista Aeronautica Marzo 1997 PS: Ohps: c'è un errore nel titolo del topic!! Qualcuno, gentilmente, può correggere lo svarione
-
La fantastica e ancora in parte poco,conosciuta "galoppata" di Corradino D'Ascanio ha inizio nel 1915 quando, inviato al fronte, si guadagna presto un encomio solenne per essere riuscito a creare un dispositivo che permetteva il riscaldamento dell'olio nei motori di una cinquantina di aerei Caudron per osservazione d'artiglieria,altrimenti inutilizzabili nel periodo invernale. In quello stesso periodo realizza e brevetta il primo inclinometro aeronautico, esegue la prima installazione radio su un velivolo italiano, esegue e collauda la prima installazione dell'autopilota Sperry, sempre su un velivolo italiano. Posto nel '17, in congedo provvisorio, D'Ascanio è destinato all'Ufficio progetti della,Società Costruzioni Aeronautiche Ing.O. Pomilio & C. di Torino. Qui partecipa alla realizzazione del prototipo del caccìa biplano monoposto Castoldi C1, che nelle prove raggiunge la velocità di ben 240 km/h. Dalla Pomilio è inviato negli USA (siamo sempre in periodo bellico) Presso la Pomilio Brothers dove partecipa alla progettazione e realizzazione degli aerei da combattimento Victory, VL8 e Liberty per le forze armate americane. Dalla lettura di alcuni documenti tuttavia, si intende chiaramente che scopo non del tutto secondario della sua missione oltreoceano era quello di creare contatti per future joint-venture Italia-USA. La sua attenzione e il suo estro creativo sono attratti da una macchina la cui idea al momento era appena abbozzata: l'elicottero. Gli studi e le realizzazioni nel campo dell'ala rotante, pur facendogli raccogliere fama e onori, in particolare all'estero ,(nemo profeta, in patria), costituirono la sua croce. Nessuna delle sue creature superò la fase di prototipo, e non certo perché non valide, ma solo per una assurda concatenazione di eventi che ha del romanzesco. A dargli fama e ricchezza fu, vent'anni dopo , l'invenzione di un piccolo veicolo terrestre: lo scooter Vespa. Entriamo ora nella parte più affascinante della storia di D’Ascanio. In molti s'erano già cimentati nello studio di una macchina a decollo verticale; l'interesse di varie forze armate,e in particolare delle marine militari, rendeva estremamente appetibile la ricerca in questo settore. La stessa Regia Marina Italiana il 12 marzo 1920 faceva pervenire alle industrie aeronautiche nazionali un bando avente per oggetto un "Concorso elicotteri". Forte delle sue esperienze in campo aeronautico, D'Ascanio si impegna a fondo negli studi progettuali. Abbandona presto le concezioni del Forlanini e dello stesso Oemichen che a Orly nel 1924 conquista il primo record di categoria volando per 525 metri a una quota di circa 10m. Anzi al riguardo esiste uno studio critico di D'Ascanio su questo apparecchio che egli definisce, non si sa quanto dispregiativamente, "elicostato", e profetizzando improbabile un suo futuro non fosse altro che per l'impossibilità del sistema di planare o paracadutare in caso di piantata del motore. Nel 1925 il progetto del primo elicottero è pronto, occorrono solo i mezzi per realizzarlo: È di quei giorni l'incontro, che per entrambi ,si rileverà negativo nel lungo termine, con il Barone Pietro Trojani, facoltoso conterraneo di D'Ascànio col quale il nostro costituisce una società per la produzione e la futura commercializzazione dell'elicottero. - . ¬ Prende così corpo il D'A.T.1, realizzato presso le fonderie Campione di Pescara. Il Trojani provvede a supportare i costi di produzione e D'Ascanio a dirigere i lavori. Il 19 maggio 1926 il prototipo è pronto al volo di collaudo nel cortile della fonderia. Ai comandi dello stesso progettista si solleva di fronte a testimoni "di almeno trenta centimetri, prima con la ruota di sinistra e poi con l'altra e col pattino di coda". Dopo pochi istanti, però, uno schianto secco all'altezza del rotore suggerisce al pilota di arrestare il motore. Il mezzo si riappoggia a terra senza altri danni. Una saldatura mal eseguita all'attacco dell'ammortizzatore di una pala: questa la causa dell'inconveniente. Riparato il danno e apportate alcune piccole migliorie non sostanziali, il D'A.T.2 (spacciato per secondo esemplare, mentre in realtà era il primo riparato) viene collaudato il 12 ottobre di quello stesso anno, questa volta sull'aeroporto di Pescara. Dopo pochi secondi di volo le pale entrano in collisione tra di loro provocando la caduta e la distruzione del prototipo. Stesso genere di problema avevano avuto tutti gli altri progettisti. D'Ascanio per primo ne comprese il motivo e corse ai ripari. L'errore consisteva nell'aver realizzato i rotori rigidi con i relativi alberi e senza aver provveduto a dotare le pale di opportuni sistemi di articolazione. Afferrato il problema, fu relativamente semplice porvi rimedio. Ciò che invece iniziava a essere problematica era la parte economica. Fino a quel momento erano stati spesi dal Trojani circa due milioni dell'epoca e un altro, secondo un preventivo dello stesso D'Ascanio, sarebbe occorso per realizzare il terzo esemplare, quello cioè che doveva essere il compendio e il coronamento di tutte le esperienze e gli sforzi precedenti. Ad ogni buon conto in quello stesso anno i due soci avevano presentato la richiesta per il brevetto industriale del loro apparecchio. Non essendo le risorse del finanziatore ,sufficienti alla bisogna, Trojani si vide costretto a ricorrere al credito bancario. Sempre il barone pescarese si adoperò presso la Regia Aeronautica per riuscire a ottenere un ordinativo di acquisto per il costruendo D'A.T. 3. E qui ci sono da fare delle considerazioni di ordine più politico che tecnico. L'elicottero interessava più alla Marina che all’Aeronautica. Al comando di quest'ultima c'era Italo Balbo, ed è ben nota la sua personale guerra contro le "aviazioni ausiliarie". lncoraggiare la costruzione di un velivolo che sarebbe servito proprio a un"'aviaziòne ausiliaria" non rientrava nei suoi piani. Questo atto di miopia fu il primo di una lunga serie di circostanze sfavorevoli çhe fecero perdere all'Italia il primato nell'ala rotante. Ma torniamo a D'Ascanio. Trojani riuscì effettivamente a ottenere una bozza di contratto di acquisto dall'Aeronautica e a condizioni eccellenti. Oltre agli ordinativi successivi, se l’apparecchio avesse soddisfatto le aspettative, erano previsti premi per un ammontare complessivo di tre milioni di lire ma, probabilmente, per via dei nuovi assetti politici al vertice dell'Arma, il capo della Direzione Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti, generale Guidoni, cancellò la parte dello schema di contratto relativa ai premi. Ad onor del vero c'è da dire che il D'A.T.3 difficilmente sarebbe stato in grado di soddisfare le specifiche che l'Aeronautica richiedeva. Si trattava comunque del migliore elicottero in quel momento realizzabile al mondo! I requisiti eccessivi dell' Aeronautica molto probabilmente avevano proprio lo scopo di mortificare il progetto. Comunque sia, fu definito il contratto per la fornitura di un elicottero per il prezzo di 600.000 lire. Basti, pensare che a tutto il 1930 gli USA avevano investito, a livello governativo, l'equivalente di 20 milioni di lire nella ricerca per l’elicottero e, la Francia più di 6 milloni. E non approdarono che anni dopo ai risultati cui arrivò il D'A.T.3, in parte copiandolo. Questo mezzo venne realizzato, dopo successive proroghe ai termini del contratto,tra il marzo del '28 e la fine d'agosto del '29 con capitali privati ottenuti in prestito dalle banche. La fabbricazione avvenne all'interno di strutture dell'Aeronautica. Le prove di volo iniziarono a settembre . All'interno dell'hangar dirigibili dell'aeroporto di Ciampino nord, e proseguirono dopo un incidente che consigliò di sostituire i pattini con ruote direzionabili. Fu anche sostituito il motore con il più potente FIAT A50S. Un altro problema, non da poco, era costituito dall' addestramento del pilota collaudatore che procedeva di pari passo con le prove, non essendoci stato in ltalia un precedente di un elicottero costruito e provato. Comunque il maggiore Marinello Nelli designato per i collaudi se la cavò in maniera encomiabile. Terminate in maniera soddifacenfe anche i test a terra, nell'ottobre del 1930 il D'A.T.3, sempre ai comandi del maggiore Nelli, si presentò in pubblico conquistando in tre prove distinte i record mondiali, - i primi omologati dalla FAI - di distanza, altezza e durata rispettivamente con 1078,60 metri, 18 metri e 8 minuti e 45 secondi. Per quanto fossero i migliori risultati fino allora ottenuti da un elicottero, si era ben lontani dall'ipotizzarne impieghi operativi. La strada era comunque quella giusta, ed era necessario continuare le ricerche e gli studi: un prototipo del genere poteva essere un punto di punto di partenza e non un mezzo da commercializzare. La logica si scontrava con la dura realtà. Il Barone Trojani aveva, giustamente, fretta di rientrare dalla sua esposizione finanziaria; D'Ascanio intendeva invece, anche lui giustamente,continuare nello sviluppo del progetto prima di proporlo al mercato. L'Aeronautica, dal canto suo, non ritenne di dover proseguire negli studi sull’ elicottero. Si fecero allora.,avanti gruppi privati americani e inglesi che si offrirono di continuare nelle ricerche. Ma Trojani chiese, per sua necessità, cifre ritenute troppo elevate per cedere,anche in parte, i brevetti. La stessa FIAT, nella persona del presidente Giovanni Agnelli , si propose per continuare la ricerca, ma, leggiamo su un documento, sembra che Trojani quando gli fu riferito di questo interessamento esclamasse: "Furbo Agnelli, prima di parlare deve depositare almeno cinque milioni..." A ogni buon conto D'Ascanio sull'esperienza del D'A.T.3 inizio la progettazione del D'A.T. 1931A, che avrebbe dovuto avere prestazioni di tutto riguardo. Ma mentre la Marina continuava a pressare per portare avanti il programma elicotteri, l'Aeronautica faceva del suo meglio per affossarlo,affermando che era opportuno attendere gli esiti di altri esperimenti, in particolare quelli dell’ ing. Scatizzi. Il progetto di quest’ ultimo venne tuttavia bocciato. La collaborazione con Piaggio Ci fu, sempre in quel periodo, un interessante progetto a opera dell'ing.Ferdinando Bordoni, che depositò un brevetto per un "Elicottero con eliche a passo variabile automaticamente e a comando". Questo studio in Italia non ebbe seguito, il progettista però lo brevettò neqli USA, dove, allo scoppiare della seconda guerra ,fu requisito dal governo americano e ampiamente utilizzato sugli elicotteri costruiti dalla Sikorsky e dalla Bell. Lo stesso Igor Sikorsky all'epoca in cui era studente di ingegneria all'Università di Firenze, attinse a piene mani dagli studi di D'Ascanio, di cui divenne buon amico per sua stessa ammissione. Il sistema di stabilizzazione e di traslazione dell'elicottero con cui Sikorsky conquistò dei primati nel 1938 erano una grossolana evoluzione di quelli del D'A.T. 3. Esauritasi in un rivolo di polemiche questa fase, anche con la rottura dei rapporti societari con Trojani, al quale D'Ascanio dovette rilasciare una obbligazione firmata,il discorso elicottero fu rinviato sine die. Rimasto a Roma, e resosi conto della possibile utilità di eliche a passo variabile, D' Ascanio ne progettò una ché propose all'attenzione del Ministero dell' Aeronautica, dove nessuno le dedicò la dovuta attenzione. Anche perché non era ancora sentita la necessità di tale ritrovato. Ma poco tempo dopo il Ministero dette incarico all'ingegner Pegna della Piaggio di progettare un aereo da bombardamento di superiori caratteristiche rispetto a quelli esistenti. Pegna obiettò che sarebbe stato utile, per sfruttare tutta la potenza dei motori, avere la possibilità di utilizzare un'elica a passo variabile. Fu così che il Generale Fiore, allora Direttore delle Costruzioni Aeronautiche, chiamò D'Ascanio pregandolo di mettersi in contatto con Pegna al fine di sottoporgli il progetto della sua elica. Questa venne ritenuta valida e prodotta senza aggiustamenti rispetto al progetto. Il successo della sua sperimentazione segnò l’avvio della produzione di eliche a passo variabile che equipaggiarono il bombaraiere P.16. Ma segnò anche l'ingresso di D'Ascanio nella Piaggio. Altre eliche da lui progettate, equipaggiarono circa l’ 80% dei velivoli italiani dell'epoca: Macchi, Caproni, Cantieri di Monfalcone, Ambrosini, Reggiane. Sempre per la Piaggio , D'Ascanio riuscì a risolvere una controvesia tra questa e la SANA, società che gestiva la linea Roma-Genova-Barcellona con dei Dornier Wall equipaggiati di motori Piaggio, correggendo un errore di installazione dei propulsori, che aveva causato dei grippaggi. Installazione che era stata curata personalmente da "Herr Dornier". Quasi contemporaneamente risolse il problema di trimmanaggio di un apparecchio scuola consegnato a Guidonia alla "Regia" e mai pagato perché considerato insicuro proprio a causa del sistema di trim. Questi due interventi fecero risparmiare o recuperare alla Piaggio svariati milioni, ma a detta di D'Ascanio egli non richiese ne ebbe alcun compenso. Venne comunque assunto dall'azienda per collaborare con Pegna alla realizzazione del P 16, ma non si limitò a questo. Progettò e realizzò un tunnel del vento di nuova concezione i cui risultati si rivelarono equivalenti a quelli del più famoso tunnel Eiffel di Parigi. E ancora una vasca per le prove idrodinamiche dell'idrovolante S 55; un sistema Froude aerodinamico per la prova al banco di motori, che gli valse un premio speciale in danaro da parte del Ministero Aeronautica; studi particolareggiati su un motore sovralimentato a due velocità che, grazie all'impiego, da lui concepito, di ossigeno liquido, consenti al generale Mario Pezzi di conquistare il record mondiale di altezza. Progettò anche una centralina ausiliaria per il tiro della contraerea che dette eccellenti risultati, un computer elettromeccanico per gestioni d'archivio, un sistema per frenare l'impatto di cose o persone paracadutate, un motore ad' aria calda, un impianto per provare i motori alla depressione corrispondente ai 5.000 metri. Tutto questo nello stabilimento di Finale Ligure. Ma il suo sogno restava l'elicottero. Nel 1935, dopo essersi trasferito allo stabilimento di Pontedera, riuscì a convincere il dottor Rinaldo Piaggio a realizzame uno e, praticamente nei ritagli di tempo, progettò e realizzò un plurirotore tripala: il P.D. che era comunque uno sviluppo del sistema del D'A.T.3. Successivamente, visto anche un rinato interesse, del Ministero, realizzò il P.D. 2,in cui compariva l'elica anticoppia (il motore era un FIAT A54 da 140 HP). Le prime prove dell'apparecchio coincisero, purtroppo, con i primi bombardamenti. Durante uno di questi venne colpito l'hangar in cui si trovava l'elicottero, che ne rimase seriamente danneggiato. Le distruzioni portate agli impianti dagli eventi bellici fermarono tutta l'attività della fabbrica. A guerra ormai quasi finita Piaggio chiamò D'Ascanio presso lo stabilimento di Biella per collaborare alla messa a punto del progetto di una piccola moto. D'Ascanio ebbe carta bianca e questi, abbandonato il progetto iniziale, realizzò una moto monoscocca, quella che lo avrebbe consacrato, per il futuro, come creatore geniale: la Vespa. Nel 1948 fu invitato negli USA a Filadelfia, per partecipare a un congresso sull'elicottero. Li, contrariamente che in patria; fu accolto con gli onori che è giùsto tributare a chi per primo era riuscito a risolvere il problema della stabilizzazione del volo verticale. E proprio in quella sede, progettisti e costruttori affermati come Sikorsky, Jvanovich e Bell, ammisero candidamente di essersi rifatti ai suoi studi per sviluppare le loro creazioni. Negli Usa ebbe anche modo di rendersi conto dei progressi fatti dall'ala rotante, soprattutto a livello industriale. Tanto che tornato in Italia e relazionatone al dottor Piaggio, lo convinse a tornare sul discorso elicottero. Forte anche del fatto che il governo aveva destinato dei fondi (finalmente) agli studi in materia. Fu recupera parte del P.D. 2, il rotore fu ricostruito e trasformato in bipala e il tutto ribattezzato P.D. 3. I primi voli della nuova macchina furono effettuati nel 1950 con ai comandi,su semplici indicazioni del progettista, Mario D'Este che non era un pilota, ma solo il disegnatore e che in molti di questi voli ebbe come passeggero l'ing. Dini. Incoraggiato dalla riuscita di questo mezzo, che certo altro non era che un prototipo sperimertale ,l'azienda decise di affidargli la progettazione di un mezzo di maggiori dimensioni e potenza. L'Alfa Romeo aveva annunciato la costruzione di un motore da 450 HP e in base a questo motore fu progettato il P.D.4, un birotore in tandem. L'Alfa, però non portò più a termine il motore annunciato e per le prove si dovette ripiegare su di un meno potente Franklin da 250 HP. Proprio questa fu una delle cause che potaroro alla distruzione del mezzo durante una prova. Ai comandi di Dall' Acqua il P.D. 4 effettuò tutta una serie di voli con risultati soddisfacenti. Durante una di queste prove, a bassissima quota, mentre era in volo stazionario una raffica di vento laterale faceva rollare il mezzo, la bassa potenza fece sì che la richiamata non risultasse sufficiente a sollevarlo prima che una delle ruote, toccando il suolo, facesse inclinare ulteriormente la macchina con conseguente urto delle pale a terra. Questo avveniva alla metà del 1952. La Piaggio decise allora di abbandonare le ricerche sull’ elicottero, anche perché aveva necessità di convogliare tutte le risorse produttive sulla Vespa, la cui richiesta cresceva giorno per giorno. Per una curiosa coincidenza proprio in quell' anno, in cui si decise di chiudere il capitolo elicotteri D'Ascanio alla Piaggio, la Società Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta firmava un accordo con la Bell Aircraft Corporation per la costruzione in serie in Italia degli elicotteri di questa casa. Per i dieci anni succesivi, cioè fino alla pensione, D'Ascanio di elicotteri ufficialmente non parla più. Non per questo demorde dal suo sogno. Rieccolo nel 1963 con il progetto di un “eliante" da addestramento primario il cui rotore è azionato da aria compressa e collegato mediante un raccordo flessibile a un compressore. L'idea piace al Ministero della Difesa Aeronautica, ma ancor più desta l'interesse del conte Domenico Agusta, che dopo contatti sottopone nel febbraio del '64 all'ormai settantatreenne ma sempre brillantissimo D'Ascanio una bozza di contratto di collaborazione e consulenza per lo sviluppo dell' eliante addestratore ed "eventuali altri ritrovati nel campo del volo verticale". Sottoscritto con entusiasmo il contratto che prevede un compenso mensile di 300.000 lire oltre a eventuali future cointeressenze, il nostro si mette alacremente all'opera. Dapprima nella sua residenza pisana e poi presso gli stabilimenti Agusta di Frosinone viene prodotto, seppure con le lungaggini burocratiche relative alle ispezioni e certificazioni del RAI, il primo elicottero ULM della storia! Pensate che con due persone a bordo il peso al decollo previsto era di 450 kg. Il motore era un MV AG 70N da 80 HP, lo stesso che equipaggiava già dal 1961 l'addestratore So 103 della Bolkow. Alcuni esemplari furono realizzati in attesa di perfezioriare il contratto di fornitura all'Aeronautica. Dai documenti esaminati risulta che la pratica fu affossata nell'ufficio di Gabinetto prima di essere sottoposta all'attenzione e alla firma dell'allora Ministro della Difesa. La scomparsa di Domenico Agusta e altri motivi di natura più politica che tecnica portarono la nuova dirigenza dall'azienda ad abbandonare il discorso dell'addestratore D'Ascanio. Questi, dal canto suo (già ottuagenario), cercò di portare avanti quest' ultimo progetto proponendolo anche per l'uso in agricoltura, ma i tempi non erano maturi. Addirittura tornò, a quarant'anni di distanza, ad interessare la FIAT. Questa però non poteva,dopo la nascita di Aeritalia, occuparsi di aeronautica Volare Ottobre 1996
-
AUGURI!!!!!!!!!!!! E SCUSA IL RITARDO
-
Beh, mettiamola così Vi sono alcuni articoli molto belli, secondo me, pubblicati su vecchie riviste che è un peccato relegarli in cantina a prendere polvere. Lo scopo è quello di renderli disponibili a coloro che magari a causa della giovane età non hanno avuto modo di poterli leggere.